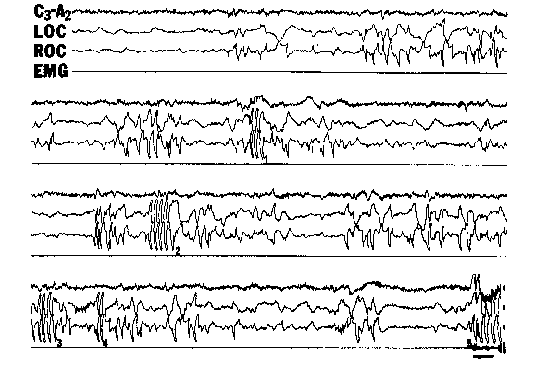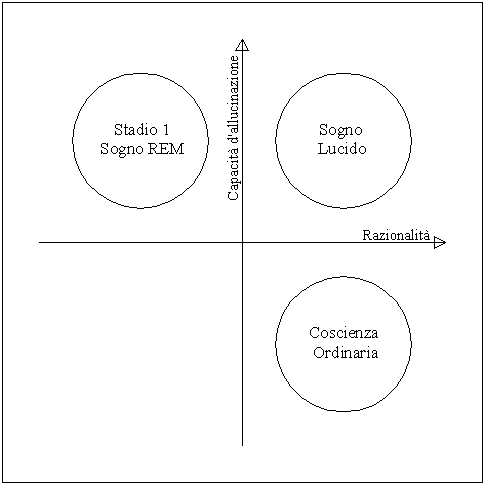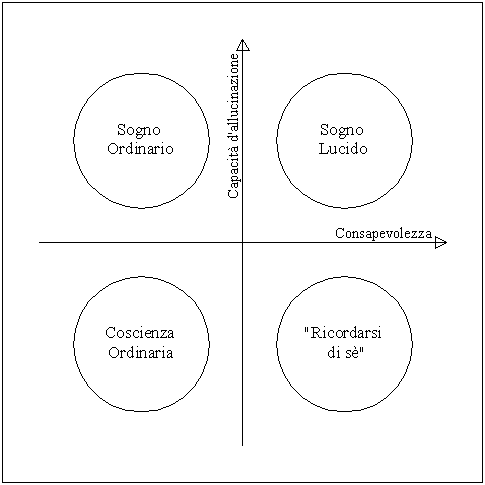Descrizione generale del fenomeno
La definizione generale del sogno lucido è che questo sia quel sogno in cui il sognatore è consapevole di star sognando, divenendo in questo modo capace di controllarne gli eventi, "di riscriverne la trama e di far muovere i personaggi con la disinvoltura di un autoritario regista di Hollywood sul set" [Hooper, Teresi, 1986, p.334].
Autori di stampo cognitivista (una delle principali correnti della psicologia contemporanea) [Moffitt, Hoffman, Mullington, Purcell, Pigeau, Wells, 1988] hanno dato una definizione del fenomeno a partire dal punto di vista dei processi cognitivi che lo caratterizzerebbero, individuando come qualità specifica distintiva del sogno lucido, rispetto ai "sogni ordinari", la presenza di processi mentali auto-riflessivi. Questi ultimi sarebbero spesso presenti nel funzionamento mentale durante la veglia in attività di vario tipo. Il pensiero auto-riflessivo, secondo l’ottica cognitivista, funzionerebbe avendo come punto di riferimento costante se stesso e sarebbe denotato da auto-ricorsività e auto-organizzazione. Considerato in questi termini, il sogno lucido sarebbe un’espressione del funzionamento mentale simile all’attività auto-riflessiva della veglia. L’ottica cognitivista porta, dunque, a considerare il sogno lucido più nelle sue similarità con il funzionamento mentale durante la veglia che nelle sue differenze con esso, con il pericolo di sottovalutare la portata del fenomeno in esame.
In questi scritti si farà costantemente riferimento alla prima definizione per due motivi. Innanzi tutto perché permette di denominare un più ampio spettro di esperienze come "sogno lucido", avendo la possibilità, così, di studiare i fenomeni che, pur non presentando le capacità cognitive simili a quelle dello stato di veglia, sono caratterizzate da consapevolezza del proprio stato di sonno. In secondo luogo la prima definizione è da preferire in quanto permette di focalizzare meglio le specificità e le potenzialità del sogno lucido come fenomeno a sé.
Il sonno, come è noto, è organizzato in cicli della durata approssimativa di un’ora e mezza, a propria volta suddivisi in stadi o fasi caratterizzati da fenomenologie psicofisiologiche tipiche rilevabili attraverso diversi strumenti quali l’elettroencefalografia, l’elettromiografia, l’elettrooculografia. Il sogno lucido avrebbe luogo principalmente durante la fase REM del sonno, fase che è caratterizzata da rapidi movimenti oculari e immobilità del resto del corpo e che dura all’incirca 20 minuti in ogni ciclo del sonno.
Mentre un sogno lucido sta avendo luogo colui che sogna può determinarne gli sviluppi in termini di scenario, personaggi, oggetti, attività e avvenimenti. La misura in cui sarà in grado di fare questo varia sia tra gli individui, sia tra le diverse esperienze di uno stesso "sognatore lucido". "Piena lucidità", sostiene LaBerge, il più noto studioso del settore, "significa sapere: ogni parte di questo sogno è nella mia mente e io ne ho la piena responsabilità. Se non voli perché pensi di non riuscirci non sei completamente lucido" [Hooper Teresi, 1986, p.339].
Taluni hanno questo tipo di esperienza spontaneamente. Tuttavia sono state sviluppate diverse §tecniche di induzione§ che permetterebbero, a detta di diversi autori, anche a chi non ha mai avuto esperienze del genere, di svilupparne la capacità.
Fenomenologia del sogno lucido
Dal punto di vista psicologico il sogno lucido ha caratteristiche sue proprie che lo differenziano sia dallo stato di veglia che dallo stato del "sogno ordinario". Per comprendere, in una trattazione introduttiva, la specificità del sogno lucido è utile descriverne le peculiarità distinguendo le seguenti aree psicologiche:
Percezione
Essendo una buona riproduzione del mondo della veglia, il sogno lucido presenta tutte le modalità sensoriali proprie della veglia: modalità visiva, auditiva, gustativa, tattile, olfattiva, propriocettiva, termica e dolorifica [Green, 1968, p.74].
Per quanto riguarda la percezione visiva per lo più vengono riportate esperienze di forte chiarezza sia per quanto riguarda la precisione dei dettagli, che riguardo la vivezza dei colori. Tuttavia esistono anche descrizioni opposte: sogni lucidi privi di colore, o dominati da uno solo di essi, come è il caso del sogno color seppia del soggetto D riportato da Green [Ibidem, p.70]. La modalità visiva sembra essere il canale percettivo dominante nei resoconti dei sognatori lucidi. Inoltre la valutazione che mira a stabilire se si sta sognando o no (il porsi da parte del sognatore la domanda: "Questo è un sogno?") passa spesso attraverso l’analisi di immagini visive.
E’ possibile anche leggere, anche se questa attività sembra richiedere un grande sforzo di concentrazione [Fox, 1962, p.46]: ogni frase o, addirittura, ogni parola deve essere mantenuta nella sfera dell’attenzione con un grande sforzo di volontà fino a che il significato non sia colto.
Memoria
L’accessibilità ai ricordi della veglia sembra variare notevolmente tra i soggetti. E’ interessante notare come questa capacità vari molto col susseguirsi delle esperienze di un singolo individuo, aumentando progressivamente mentre viene sviluppata la possibilità di avere sogni lucidi [Green, 1968, p.90].
Il recupero delle informazioni specifiche e i dettagli riguardanti la vita recente o prossima futura dei soggetti (ad esempio gli impegni del giorno dopo) è più difficoltoso che nello stato di veglia. Eccettuato questo ambito le capacità di recupero del sognatore lucido sembrano essere altrettanto buone che nella veglia: informazioni circa le caratteristiche fisiche degli oggetti, questioni psicologiche e filosofiche o circostanze della propria vita lontane dal momento attuale sono tutte facilmente ricordate in un sogno lucido.
Pensiero razionale
La capacità di pensare in modo razionale ha un’unica eccezione che riguarda i ragionamenti circa la relazione tra il mondo del sogno e il mondo della veglia [Ibidem, p.91]. Sebbene il sognatore lucido sia consapevole della condizione di indipendenza tra le due realtà, a volte se ne dimentica e i suoi ragionamenti si fanno contraddittori. Myers [Myers, 1887, p.242] riporta un sogno lucido in cui si ricorda del fatto che i suoi familiari, nel mondo reale, sono assenti da casa. Il sogno si svolge nella casa stessa e il protagonista, pur essendo consapevole di star sognando e, quindi, della indipendenza tra mondo onirico e mondo reale, si stupisce di incontrare moglie e figli. Myers non vede la contraddizione tra il sapere di star sognando e l’aspettarsi che il sogno si conformi con la realtà. Green [ibidem] rileva come spesso vi sia una vera e propria resistenza psicologica a considerare il sogno come indipendente dal mondo fisico.
Emotività
La qualità emotiva dei sogni lucidi è molto variabile comprendendo un estremo di assenza completa di emozioni, fino all’estremo opposto dove può essere presente una intensa eccitazione ed emozioni di gioia o sorpresa, come anche emozioni estremamente penose di paura o rabbia. Il seguente è un esempio [Myers, 1887, p.241-242, traduzione mia] che presenta un alto grado di emotività: il soggetto ha un sogno ordinario che si svolge in una mattinata estiva. Il soggetto si trova sul marciapiedi fuori casa propria. C’è, però, qualcosa che non va, le pietre che formano la trama della pavimentazione durante la notte hanno subito una rotazione di novanta gradi. Il fatto è incredibile, il sognatore è incredulo, poi improvvisamente si rende conto di essere in un sogno: "Allora in un lampo ebbi la soluzione: sebbene questa meravigliosa mattinata estiva sembrasse davvero reale, io stavo sognando. Dopo aver realizzato questo fatto, il sogno mutò in un modo che sarebbe molto difficile da comunicare ad una persona che non abbia mai avuto questo tipo di esperienza. All’istante la vivezza di tutto ciò aumentò di cento volte. Mai avevo visto il mare e il cielo e gli alberi risplendere di una simile luce affascinante; anche le comuni case sembravano vive e di una bellezza mistica. Mai mi ero sentito così bene, così chiaro nel pensiero, così divinamente potente, così indicibilmente libero! La sensazione era squisita oltre ogni dire; ma durò solo pochi momenti, e mi risvegliai. Come avrei imparato più tardi, la mia capacità mentale di controllo era stata sopraffatta dalle emozioni". Come si comprende dall’esempio e come rilevano molti sognatori lucidi abituali, la capacità di controllare le proprie emozioni, ossia di mantenersi distaccati da esse ha un diretto effetto sulla possibilità di mantenersi lucidi e quindi di prolungare l’esperienza [Green, 1968, p.99].
Oltre alle emozioni di qualità positiva, di cui si è fatto nota, vi sono casi di esperienze emotive radicalmente negative, quali il panico e l’orrore. Queste incorrono specialmente in quegli individui che Green definisce "sognatori non sofisticati" ("unsophistycated dreamers"), persone a cui i sogni lucidi capitano senza averne mai sentito parlare in precedenza e, quindi, senza aver ricercato attivamente l’esperienza. Talvolta questi vengono sopraffatti da un senso opprimente di claustrofobia non riuscendo, né vedendo la possibilità, di interrompere il sogno.
Interazione con il mondo onirico
Il mondo sperimentato nei sogni lucidi è molto simile al mondo reale, o, meglio, al mondo come viene sperimentato durante la veglia. Sebbene il sogno lucido inizi sovente con il divenire consapevoli di una palese incongruenza, questa, una volta rilevata ed essendo avvenuto così il passaggio alla "lucidità", tende a scomparire. Le sole stranezze del mondo dei sogni lucidi sono quasi sempre le nuove abilità del sognatore come ad esempio la capacità di volare o di attraversare gli oggetti, abilità che sarebbero nel mondo reale denominate "fenomeni psicocinetici" [Ibidem, p.56], oggetto di attenzione più della parapsicologia che della psicologia. Interessante è notare come tali fenomeni si presentino in modo relativamente costante nei sogni lucidi di numerosi sognatori.
Escludendo i "fenomeni psicocinetici", dunque, il mondo del sogno lucido è in genere simile a quello reale: gli oggetti e i personaggi mantengono una loro stabilità e realtà e non si trasformano in qualcosa di diverso con la disinvoltura con cui ciò avviene nei sogni consueti [ibidem]. Non compaiono oggetti o personaggi assurdi e incongruenti con il reale: non compaiono alberi con gli occhi e parlanti né uomini con cinque braccia.
All’interno dello scenario del sogno il sognatore possiede un corpo generalmente uguale a quello reale che potrebbe essere chiamato "corpo del sogno". Neanche il corpo del sognatore, nonostante possa non assomigliare a quello reale, subisce dei cambiamenti durante il sogno, ma si mantiene per lo più stabile nel corso del sogno lucido.
Volare è una componente del sogno lucido molto spesso rilevata da coloro che ne hanno vissuto e descritto l’esperienza. A volte il poter volare rappresenta proprio il discrimine che permette di stabilire di star dormendo e di non essere svegli. Il volare, o il galleggiare nell’aria, viene sempre descritta come una esperienza assai piacevole. I sognatori possono aver bisogno di supporti da cui spiccare un balzo, ovvero immaginano di nuotare nell’aria dandosi spinte con braccia e gambe, altre volte si muovono senza trovare resistenza alcuna dirigendosi direttamente dove è loro intenzione andare. Sembra inoltre che l’abilità nel volo sia oggetto di apprendimento attraverso il ripetersi delle esperienze. "Storiche" descrizioni delle esperienze di volo sono quelle di Ouspensky [Ouspensky, 1960] e di Van Eeden [Van Eeden, 1913]. Quest’ultimo associa l’incidenza di "sogni ordinari" di volo con la probabilità di avere sogni lucidi.
Cenni storici e culturali
Il primo ad aver tramandato la nozione di sogno lucido entro la cultura occidentale sembra essere stato Aristotele, secondo il quale colui che sogna cade nell’illusione di interpretare le immagini di sogno come fatti reali. Il sognatore avrebbe, però, la possibilità di rendersi conto, attraverso le sensazioni fisiche esterne, di essere addormentato e da ciò inferire di star sognando [Aristotele, 1952, pp.702-706]. LaBerge sostiene che questo sia vero solo in parte: in realtà prima si diviene consci di star sognando, poi se ne deduce di essere addormentati [LaBerge, 1988a, p.11]. Ciò che interessa notare è come il fenomeno fosse noto sin dagli albori della cultura cosiddetta occidentale, in particolare al filosofo, passato alla storia come l’emblema di quel metodo di conoscenza chiamato scientifico. Come vedremo, però, per lungo tempo il mondo della scienza ha disertato questo campo di ricerca, che ha avuto uno sviluppo, in termini di pubblicazioni e finanziamenti, solo a partire dagli anni ‘70.
Nel 415 sant’Agostino citò in una lettera il racconto di un sogno lucido sperimentato da Gennadius, un fisico cartaginese, e ne discusse le possibilità [Kelsey, 1974, pp.274-275].
Gli insegnamenti circa i sogni lucidi rappresentano uno dei sei argomenti (o leggi, o yoga), attribuiti a Naropa, il maestro indiano di Buddismo tantrico del decimo e undicesimo secolo dopo Cristo. Naropa trasmise i sei yoga, incluso quello riguardante il sogno lucido a Marpa, un tibetano che introdusse questa conoscenza in Tibet. Attraverso l’esercizio gli adepti divengono capaci di controllare i propri sogni a piacimento, decidendo quando cambiare sogno e cosa visualizzare in sogno. Tale pratica avrebbe lo scopo di far sperimentare l’illusorietà dei propri contenuti onirici al fine di portare tale sensazione di illusorietà anche nello stato di veglia. E’ dunque parte del sistema religioso-filosofico del Buddismo tibetano che sostiene l’illusorietà di ogni aspetto della vita terrena.
Nel dodicesimo secolo si trovano tracce della conoscenza dei sogni lucidi nella cultura islamica. Si ritiene che Ibn El-Arab, importante maestro sufi, affermasse che "una persona deve controllare i pensieri in un sogno. Lo sviluppo di questo stato di allerta porterà grandi benefici all’individuo. Tutti dovrebbero applicarsi per raggiungere questa capacità di così grande valore" [Shah, 1964, p.141].
Nel tredicesimo secolo san Tommaso d’Aquino menzionò i sogni lucidi citando Aristotele e aggiungendo che questi hanno luogo in special modo "verso la fine del periodo del sonno, negli uomini sobri e in quelli che sono dotati di grande immaginazione" [Aquinas, 1947, p.430].
Il filosofo del diciassettesimo secolo Gassendi aveva sogni lucidi e quindi poté parlare dell’esperienza come di un fatto sperimentato in prima persona. Le sue annotazioni in proposito sono, dunque, particolarmente interessanti. Ciò è vero in special modo allorché descrisse il passaggio dal sogno ordinario alla lucidità. Gassendi si imbatteva in un contenuto assurdo, una incongruenza che lo faceva dubitare di stare vivendo una esperienza reale. In seguito a questo ragionamento diveniva lucido: "Questo è precisamente ciò che mi accade allorché mi sembra di vedere degli uomini e allo stesso tempo mi ricordo del fatto che sono morti. All’improvviso mi sopraggiunge il pensiero che io possa star sognando poiché gli uomini morti non tornano indietro" [Brush, 1972, p.195, traduzione mia].
Anche il filosofo Thomas Reid raccontava in una lettera del 1779 di essere riuscito dopo numerosi tentativi a rendersi conto di star sognando. Reid racconta di aver sofferto di incubi di una tale intensità da lasciarlo terrorizzato anche il giorno seguente. Prese, quindi, l’abitudine di andare a letto ripetendosi pensieri rassicuranti del tipo: "L’incubo è, in realtà, solo un sogno; non ho niente da temere nella vita reale". Per lungo tempo questo trattamento non ebbe effetto, poi cominciò a rendersi conto di trovarsi a vivere un incubo in una condizione di sogno e quindi di sicurezza. Con questa consapevolezza incominciò ad affrontare l’incubo ricorrente di scivolare in un abisso lanciandosi volontariamente nel vuoto. Poi "...immediatamente mi svegliavo. Tuttavia mi svegliavo calmo, il che pensavo fosse un risultato migliore"[Seafield, 1865, p.194]. In seguito Reid smise di avere sogni spiacevoli e, poco tempo dopo, cessò completamente di ricordare i propri sogni.
Di fondamentale importanza nello studio dei sogni lucidi è stato il Marquis d’Hervey de Saint-Denys che nel 1867 pubblicò anonimamente: "I sogni e i mezzi per dirigerli", documentando venti anni di ricerche ed esperimenti su di sé sul tema dei sogni lucidi. Tra l’altro nel libro veniva descritta la tecnica elaborata da Marquis per aumentare la capacità di controllarli. Le indicazioni dell’autore si compongono di una serie di capacità da acquisire in progressione: innanzi tutto bisogna aumentare la propria capacità di ricordare i sogni; in secondo luogo bisogna imparare a divenirne consapevoli; poi bisogna imparare a svegliarsi durante un sogno lucido; infine si sviluppa la capacità di dirigerne la trama. Tuttavia pochi riuscirono a sviluppare tale capacità alla stregua di Marquis. Frederich W. Myers, uno dei fondatori della inglese Society for Psychical Research, si lamentava del fatto che, nonostante i suoi sforzi, fosse riuscito ad avere sogni lucidi solamente tre volte rispetto alle tremila in cui aveva tentato [Myers, 1887, pp.241-242].
Anche uno dei più importanti filosofi del diciannovesimo secolo, Friedrich Nietzsche, affermava di avere sogni lucidi [deBecker, 1965, p.139].Va notato che in quel secolo la nozione di sogno lucido non era ancora entrata nel campo della ricerca scientifica. Il dibattito in proposito consisteva di testimonianze a favore o di opinioni che ne negavano la possibilità di esistenza. Tra queste ultime troviamo quella dello psicologo francese del diciannovesimo secolo Alfred Maury, un pioniere nello studio scientifico dei sogni. Dello stesso parere era anche il famoso psicologo inglese Havelock Ellis. Tra i sostenitori c’era, invece, Ernest Mach dell’Università di Vienna, che riporta le sue personali esperienze in un testo del fine Ottocento [Mach, 1900, pp.114-115]. Sempre a Vienna, nel 1900, viene pubblicata la celeberrima opera di Freud sui sogni: "L’interpretazione dei sogni". In questa prima edizione non si fa nota dei sogni lucidi, che compaiono, appena accennati, nella seconda e nella quarta edizione.
Nel ventesimo secolo i contributi aumentano esponenzialmente via via che si avvicinano ai nostri giorni. Allo psichiatra olandese Frederik Willems van Eeden si deve il termine "sogno lucido". Questi tenne un diario della sua attività onirica dal 1898 al 1912, con un particolare interesse per i sogni lucidi. "In questi sogni lucidi", afferma "la reintegrazione delle funzioni psichiche è così completa che il sognatore raggiunge uno stato di consapevolezza perfetta ed è capace di dirigere la propria attenzione, e di compiere diverse azioni in piena libertà. Tuttavia il sonno, per quanto ho potuto in buona fede rilevare, è indisturbato, profondo e riposante" [van Eeden, 1913, p.438, traduzione mia]. Contemporaneamente a van Eeden, Yves Delage portava avanti studi simili in Francia, non divenendo tuttavia un sognatore lucido abituale, ma descrivendo le sue poche esperienza nel 1919 [Delage, 1919]. Sempre nello stesso periodo in Inghilterra Hugh Calloway, che si fece però pubblicare con lo pseudonimo di Oliver Fox, conduceva esperimenti contemporaneamente sui sogni lucidi e su fenomeni occulti. Calloway chiamava i primi: "sogni di conoscenza ("dreams of knowledge"), poiché in tale stato si aveva la conoscenza di star sognando [Fox, 1962].
Negli anni Venti, Ram Narayana, un indiano formatosi in Inghilterra, somministrò un questionario sull’argomento dei sogni a individui sia occidentali che orientali di varie classi, ceti, caste e religioni. Una delle domande chiedeva se, secondo l’intervistato, fosse possibile mantenersi coscienti durante i sogni e, se così, attraverso quali mezzi fosse possibile aumentare tale capacità. I risultati mostrarono che la conoscenza, diretta o indiretta, del fenomeno era più diffusa tra gli individui orientali che tra quelli occidentali [Narayana, 1922].
Nel 1924 Thomas Mann nel romanzo "La montagna incantata" [Mann, 1969] fece vivere al protagonista un sogno lucido, che, nell’ambito della trama, era estremamente rivelatorio fino al punto di permettergli di risolvere il filosofico conflitto della vita e della morte.
Nel 1931 il filosofo russo Ouspensky, fuoriuscito in Inghilterra, descrisse quelli che chiamava "stati di sogno a metà" ("half-dream states"), come sogni in cui è possibile essere coscienti e pensare coscientemente [Ouspensky, 1960]. Diversamente dalla maggioranza dei ricercatori, Ouspensky era unicamente interessato a sviluppare una maggiore capacità di osservazione dei fenomeni onirici al fine di comprenderne meglio la formazione, mentre non si curò mai di imparare a controllarne gli eventi.
Sempre nel periodo tra le due guerre, comparvero su riviste scientifiche due articoli sull’argomento: il primo nel 1936 di A. E. Brown [Brown, 1936], il quale affermava di aver avuto circa cento esperienze; il secondo nel 1938 in Germania di Harold von Moers-Messmer [Moers-Messmer, 1938].
Nel dopoguerra, nel 1948, Nathan Rapport, uno psichiatra americano, decantò la piacevolezza di questo tipo di esperienza in un articolo intitolato: Sogni piacevoli ("Pleasant dreams") [Rapport, 1948]. I sogni lucidi colpivano, e colpiscono, il sognatore per la loro intensità e davano l’impressione di essere estremamente significativi. Questa qualità di esperienza forte portò H. M. Whiteman, un matematico della University of Capetown a esclamare nel 1961: "Non sono mai stato sveglio prima!" [Whiteman, 1961, p.186]. Nello stesso periodo lo psicologo Kilton Riggs Stewart [1962, 1972], che negli anni Trenta aveva viaggiato tra la popolazione Senoi della Malesia, nei suoi scritti attribuiva a tale popolazione una diffusa capacità di controllare la propria attività onirica ed una serie di pratiche per svilupparla. Inoltre Stewart faceva derivare da tale abilità lo stile di vita pacifico dei Senoi. Gli scritti Di Stewart hanno avuto grande risonanza specialmente tra gli studiosi di sogni americani. Tuttavia ricerche etnografiche successive [Dentan, 1988] evidenziano come, nonostante i Senoi pongano molta attenzione alla vita onirica in genere, in realtà tra di essi la capacità di avere sogni lucidi è molto meno diffusa di quanto fosse stato riferito da Stewart.
Il primo testo di riferimento dei nostri giorni è apparso nel 1968 ad opera di Celia Green. Questo libro rappresenta una elaborazione attenta e sistematica delle conoscenze sviluppate dai precedenti autori che si sono occupati del fenomeno. Questo paragrafo si fonda ampiamente sui dati storico-culturali presenti in questo testo, nonché sull’articolo di LaBerge: "Lucid dreaming in western literature" [Laberge, 1988a].
Negli ultimi venti anni l’argomento è divenuto sempre più presente all’attenzione sia scientifica che popolare. Le pubblicazioni scientifiche sono divenute numerose in seguito all’ingresso del sogno lucido all’interno del laboratorio del sonno.
Distinzioni concettuali
Occorre distinguere i sogni lucidi dai seguenti fenomeni:
OBE
Nelle OBE ("out of body experience"), esperienze fuori dal corpo, il soggetto sembra vedere il proprio organismo fisico dall’esterno proprio come se fosse il corpo di qualcun altro [Green, 1968, p. 8]. Questa esperienza non ha mai luogo durante un sogno lucido dove il soggetto pur possedendo nuove possibilità e capacità non ha l’impressione di avere un "altro corpo". Inoltre i soggetti che hanno sperimentato delle OBE, affermano che le loro esperienze abbiano avuto luogo nel mondo reale della veglia, mentre i sognatori lucidi sono convinti che le loro esperienze riguardino lo stato di sogno, qualunque opinione essi abbiano circa la relazione tra sogni e realtà.
Irwin, in un articolo che mira a riassumere le diverse ricerche che hanno studiato contemporaneamente il sogno lucido e l’OBE, conclude che vi siano sufficienti dati per sostenere una correlazione statistica tra i due fenomeni. La relazione tra i due fenomeni sarebbe statisticamente significativa, ma debole e scarsamente predittiva.
Pre-lucid dream
Pre-Lucid Dream. Sono così chiamati [Ibidem, p.23] quei sogni in cui il soggetto comincia a sviluppare un senso critico circa l’esperienza che sta vivendo, addirittura può arrivare a chiedersi se sta sognando, tuttavia o dimentica di rispondere a questa domanda, oppure vi risponde negativamente. Conclude, anche in seguito ad accurate prove, di non star sognando, di essere sveglio e che quanto lo circonda sia "reale". Il sogno continua nel suo modo abituale senza che il dubbio si riproponga ulteriormente.
Un tipo particolare di pre-lucid dream è il "falso risveglio" ("false awekening): si sogna di essersi risvegliati, magari nel proprio letto nella propria stanza, ma il sogno continua. Questo fenomeno, piuttosto raro, sembra aver luogo precipuamente in coloro che fanno anche sogni lucidi. Questi possono sperimentare il "falso risveglio" dopo un sogno lucido. A questo punto possono chiedersi se stanno continuando a sognare o no, ed eventualmente cercare freneticamente delle conferme aggirandosi nella propria camera da letto. Se comprenderanno di non essersi svegliati avrà luogo un altro sogno lucido, altrimenti il sogno rimarrà un pre-lucid dream.
ISP
ISP, isolated sleep paralysis, è l’esperienza in cui l’individuo addormentato diviene consapevole del proprio corpo fisico e delle relative percezioni di questo (postura supina o prona, caldo o freddo, ecc.), senza avere la capacità di muoversi o parlare. A questo fenomeno sono spesso associate allucinazioni visive o uditive ed emozioni fortemente spiacevoli di tipo claustrofobico. Le registrazioni polisonografiche [Tateuki, Myasita, Sasaki, Inugami, Fukuda, 1992] hanno rilevato una attività elettroencefalografica simile a quella del sonno REM o della veglia con un’alta presenza di onde alfa, accompagnata dalla profonda atonia muscolare tipica della fase REM.
Vivid dreams
Van Eeden [1913] chiamava "vivid dreams" quei sogni estremamente realistici, che producono una profonda impressione sul sognatore, impressione che può durare per alcune ore o addirittura giorni. Tali sogni sono sempre facilmente richiamati alla memoria e sembrano "significare qualcosa di più", veicolare un non meglio specificato "messaggio profetico". Il contenuto è assurdo, impressionante, e, afferma l’autore, spesso estremamente spiacevole o, al contrario, estremamente piacevole.
"Sogni ordinari"
In questo scritto si definiscono "sogni ordinari" tutte le forme di attività psichica durante il sonno non denotate dalla consapevolezza di stare dormendo, a prescindere dalle diverse tipologie in cui possono essere catalogate.
Talvolta, e a torto, i "sogni ordinari" possono essere scambiati per sogni lucidi. Questo avviene quando, paradossalmente, il sognatore sogna di fare un sogno lucido pur non avendo la consapevolezza di star sognando. Durante un sogno è possibile pensare: "questo è un sogno" e integrare questo pensiero all’interno di un "sogno ordinario", senza che il sognatore divenga consapevole di essere addormentato e di vivere in un mondo onirico completamente frutto della propria vita mentale, un mondo "irreale" in quanto tutto individuale, non consensuale. In questo caso, il soggetto non controlla gli avvenimenti del sogno, e, semplicemente, non è "lucido". A questo proposito Tart afferma che avere in un sogno il pensiero: "questo è un sogno" (o qualche variante di esso) è condizione necessaria e non anche sufficiente affinché abbia luogo un sogno lucido [Tart, 1979, p.94]. Secondo l’autore l’esperienza cruciale per stabilire se si sta parlando di sogni lucidi o no consiste nello sperimentare una consapevolezza identica a quello dello stato di coscienza della veglia.
Psicofiologia del sogno lucido
Il sogno lucido nel laboratorio del sonno
Fino al giorno in cui non si è avuta una empirica verifica del fenomeno all’interno di un laboratorio, chiunque poteva esprimersi sull’esistenza dei sogni lucidi, sia a favore che contro, senza che le sue affermazioni potessero essere confutate, e quindi, verificate. Le affermazioni erano basate su esperienze soggettive non verificabili.
Nel 1978 Hearne, nel suo dottorato di ricerca, ha riportato la prima verifica empirica del fenomeno presentando le registrazioni polisonnografiche (il polisonnografo registra vari movimenti muscolari del dormiente, il suo elettro-encefalo-gramma, il suo elettro-cardio-gramma) di un soggetto molto esperto nella capacità di avere sogni lucidi. Questi era stato preventivamente istruito a inviare specifici messaggi attraverso i propri movimenti oculari, che furono così rilevati durante otto sogni lucidi, tutti durante fasi REM del sonno.
Negli studi di Hearne [1978], di LaBerge, Nagel, Dement e Zarcone [1981] e in molti studi successivi i soggetti sperimentali hanno comunicato volontariamente con gli sperimentatori per lo più dalla fase REM del sonno. Tali comunicazioni avevano luogo attraverso i movimenti degli occhi e la contrazione della muscolatura degli avambracci, che i soggetti mostravano di poter controllare volontariamente allorché divenivano consapevoli di star sognando. I soggetti erano in grado di riprodurre sequenze di movimenti oculari stabilite insieme agli sperimentatori durante la veglia, ovvero producevano nuove sequenze di cui avevano memoria una volta risvegliatisi. Addirittura, con il procedere degli esperimenti, i soggetti arrivarono a comunicare, esprimendosi nel codice morse, delle parole e delle iniziali di nomi.
Tali esperienze hanno dimostrato che è possibile, per alcuni individui, controllare volontariamente il movimento degli occhi durante il sogno. Conseguentemente le stesse esperienze hanno anche dimostrato la possibilità, per alcuni individui, di essere consapevoli di star sognando, in quanto tale consapevolezza è la condizione necessaria della capacità di compiere movimenti volontari con un intento comunicativo. Hanno dimostrato la realtà del sogno lucido.
Per questo motivo i suddetti studi hanno avuto un valore fondamentale nella storia della ricerca nel campo del sogno lucido. Infatti da quel momento l’assunto: "Esiste il fenomeno del sogno lucido" è divenuta una affermazione scientifica in senso popperiano. Karl Popper sosteneva [Popper, 1970] che una affermazione, per essere scientifica, dovesse essere passibile di falsificazione, doveva lasciare una porta aperta alla possibilità di essere smentita dai fatti osservabili. Ora, dal momento che è possibile verificare l’assunto: "X è, talvolta, consapevole di star sognando" attraverso l’uso del polisonnografo, l’assunto stesso diviene una affermazione di dignità scientifica (sempre che si accetti il pensiero epistemologico di Popper).
Una volta considerata la natura scientifica della affermazione circa l’esistenza del fenomeno, bisogna attirare l’attenzione sul pericolo di attribuire tale caratteristica di scientificità ad ogni studio in materia di sogno lucido. Ad esempio le favorevoli testimonianze dell’uso del sogno lucido in clinica e psicoterapia, essendo tali testimonianze soggettive, non falsificabili né, dunque, verificabili, non sono una forma di sapere scientifico, per lo meno secondo la concezione epistemologica di Popper.
L’argomento del sogno lucido è stato indagato attraverso strumenti scientifici, ma anche attraverso strumenti non scientifici, peculiarità comune a molti altri argomenti di pertinenza della psicologia. E’ importante avere chiara questa distinzione.
La Fig.1 riporta il tracciato polisonnografico di 8 minuti di sonno REM in cui ha avuto luogo un sogno lucido. In questo caso il polisonnografo ha registrato l’elettroencefalogramma (C3-A2), l’elettrooculogramma (LOC, ROC) e l’elettromiogramma (EMG). Quest’ultimo, come si può vedere non presenta oscillazioni in quanto al momento della registrazione il soggetto si trovava durante la fase REM del sonno. Negli ultimi istanti del tracciato, nel momento segnato dal numero 5, ha luogo il risveglio. A questo punto l’elettromiogramma riporta delle contrazioni muscolari.
Al risveglio il soggetto ha affermato di aver inviato, attraverso i movimenti degli occhi, 5 segnali. I segnali sono indicati nella figura con i numeri da 1 a 5. Il segnale numero 1 testimonia l’inizio del sogno lucido ed è costituito da due coppie di movimenti oculari da sinistra (Sx) a destra (Dx). Complessivamente si compone di quattro movimenti: Sx-Dx-Sx-Dx. Nei successivi 90 secondi il soggetto ha riferito di aver esplorato il mondo onirico volando fino al momento in cui ha creduto di essersi svegliato. A questo punto (2) ha prodotto il segnale precedentemente stabilito per comunicare il risveglio: quattro coppie di movimenti oculari (Sx-Dx-Sx-Dx-Sx-Dx-Sx-Dx). Per altri 90 secondi il soggetto ha creduto di essersi svegliato pur essendo ancora addormentato. Trattasi di un "falso risveglio". Allorché si è reso conto di stare ancora sognando (3) ha segnalato questa sua consapevolezza attraverso tre paia di movimenti oculari (Sx-Dx-Sx-Dx-Sx-Dx). Riconoscendo di aver effettuato troppi movimenti oculari, il soggetto ha subito dopo prodotto il segnale corretto: due coppie di movimenti, Sx-Dx-Sx-Dx. Dopo altri 100 secondi ha avuto luogo il risveglio (5), correttamente segnalato: Sx-Dx-Sx-Dx-Sx-Dx-Sx-Dx.
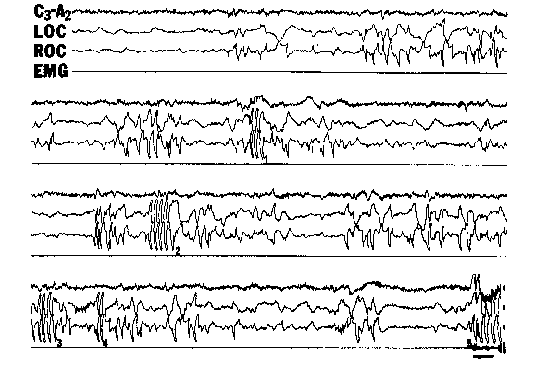
Fig. 1: Un sogno lucido verificato attraverso movimenti oculari [figura tratta da: LaBerge, 1992, p. 293]
Il sogno lucido e la fase REM
Nel 1978 alcuni ricercatori [Olgivie, Hunt, Sawicki, McGowan, 1978] stavano cercando di scoprire in quale fase del sonno avessero luogo i sogni lucidi. La metodologia utilizzata in questo caso era elementare e poco probante: i sognatori venivano svegliati durante le fasi REM del sonno e veniva chiesto loro di riferire i sogni. In tre casi i soggetti riferirono di essere stati consapevoli di star sognando. Gli autori ne conclusero: il sogno lucido dovrebbe aver luogo durante la fase REM. Il condizionale, a quello stadio della ricerca, era d’obbligo non potendo la ricerca dimostrare se i sogni lucidi fossero avvenuti immediatamente prima del risveglio, e quindi durante il sonno REM, ovvero molto tempo prima, e quindi durante il sonno non-REM.
LaBerge insieme ai suoi colleghi della Standford University [LaBerge, Nagel ,Dement, Zarcone, 1981] ha messo in luce come il fenomeno studiato riguardi prevalentemente la fase REM, ma non solo. La sua ricerca ha utilizzato la tecnica della segnalazione attraverso i movimenti oculari e le contrazioni della muscolatura degli avambracci durante il verificarsi del sogno lucido. I segnali del sognatore lucido consistevano in specifici movimenti oculari, rilevati attraverso l’elettrooculografia (EOG), e contrazioni degli avambracci, rilevate attraverso elettromiografia (EMG). Veniva rilevata anche l’attività elettroencefalografica (EEG). I soggetti, che partecipavano a questi rilevamenti in un laboratorio del sonno, venivano precedentemente addestrati a compiere specifici movimenti oculari allorché l’esperienza del sogno lucido avesse avuto luogo. Dovevano muovere gli occhi secondo la sequenza: Sx-Dx-Sx-Dx. L’EOG, così, tracciava nettamente la sequenza: su-giù-su-giù, mentre contemporaneamente l’EEG rilevava le onde del sonno (Fig.1). Nel corso di 34 notti furono rilevati 35 sogni lucidi di cui: 32 durante la fase REM, 2 durante la fase 1 del sonno non-REM, 1 durante la transizione dalla fase 2 non-REM alla fase REM. Ciò sembrerebbe dimostrare come il fenomeno in esame appartenga principalmente alla fase REM del sonno.
Alcune ricerche, che hanno studiato il sogno lucido considerandolo un fenomeno di quasi esclusiva pertinenza del sonno REM, ne hanno confermato la presenza durante la fase del "sonno paradosso". Questo è il caso delle ricerche che hanno studiato la relazione tra sogno lucido e riflesso di Hoffman. La soppressione del riflesso di Hoffman, il riflesso elettricamente evocato di una monosinapsi spinale, viene spesso considerata la caratteristica che discrimina il sonno REM dal resto del sonno. Diversi autori [Brylowski, 1987; Brylowski, Levitan, LaBerge, 1989] hanno studiato la soppressione di tale riflesso durante il sogno lucido. In particolare Brilowski, Levitan e LaBerge [1989] hanno osservato per quattro notti, attraverso la metodologia della comunicazione con i movimenti oculari, un sognatore lucido esperto. Il riflesso veniva evocato e misurato ogni 5 secondi. Le misure della soppressione del riflesso sono state confrontate tra fasi REM con sogni lucidi e fasi REM senza sogni lucidi. I ricercatori hanno osservato che il riflesso di Hoffman era significativamente più soppresso nelle fasi REM con sogni lucidi che nelle fasi REM senza sogni lucidi.
Anche gli studi, che hanno analizzato come vari quantitativamente la presenza del fenomeno nell’arco della notte, hanno testimoniato a favore della presenza dei sogni lucidi durante la fase REM. Come è stato da tempo notato [Van Eeden, 1913] i sogni lucidi compaiono maggiormente durante le ultime ore del sonno. LaBerge [1979]ha ipotizzato che tale distribuzione di frequenza rifletta semplicemente la maggiore presenza di sonno REM nelle ultime ore del sonno. Inoltre sempre LaBerge [1980a]ha evidenziato che la distribuzione della frequenza dei sogni lucidi, osservata attraverso la rilevazione di movimenti oculari volontari, nelle prime tre fasi REM non differisce significativamente dalla distribuzione della frequenza dei sogni lucidi stimata in base alla lunghezza media delle stesse fasi REM. Dunque i sogni lucidi hanno una distribuzione quantitativa che rispecchia il variare della lunghezza delle fasi REM, e quindi hanno luogo, prevalentemente (ma come si è visto non solo) durante la fase REM.
Elettroencefalogramma del sogno lucido
L’elettroencefalogramma dei sogni lucidi è significativamente diverso da quello dei sogni non-lucidi?
Olgivie, Hunt, Tyson, Lucesnu, Jeakings [1982] cercarono di verificare la propria ipotesi che il sogno lucido, rispetto all’ordinario sonno REM, fosse caratterizzato da alti livelli di attività alfa, in uno studio con 10 soggetti esperti nelle capacità di ricordare i propri sogni e di avere sogni lucidi. Ogni soggetto passò due notti in un laboratorio dove veniva svegliato durante le fasi REM per essere interrogato circa la propria attività onirica in corso. I soggetti potevano essere risvegliati durante un alto livello di attività alfa del sonno REM, ovvero durante un basso livello di attività alfa. I dati raccolti convalidarono l’ipotesi di partenza. Tuttavia una ricerca di un anno più recente[Olgivie, Hunt, Kushniruk, Newman, 1983] che ha utilizzato la stessa metodologia non ha evidenziato una differenza statisticamente significativa per quanto riguarda la presenza di sogni lucidi tra periodi REM ad alto livello di attività alfa e periodi REM a basso livello di attività alfa. Ulteriori ricerche sembrano essere necessarie per rispondere al quesito iniziale.
Gackenbach, invece, ha cercato di applicare la nozione di sincronizzazione interemisferica al fenomeno del sogno lucido in un articolo in cui propone un parallelismo tra questo fenomeno e la Meditazione Trascendentale [Gackenbach, Cranson, Alexander, 1986]. Sebbene vi siano diverse osservazioni [Orme-Johnson, Hayenes, 1981; French, Beaumont, 1984] della correlazione positiva tra Meditazione Trascendentale e sincronizzazione interemisferica misurata attraverso la Coerenza dell’EEG (in genere definita come la stima statistica della correlazione tra coppie di segnali elettroencefalografici della stessa frequenza), non si hanno dati sulla sincronizzazione intercerebrale durante il sogno lucido. Rimane, comunque, il valore euristico dell’ipotesi.
L’oggetto di studio della lateralizzazione della attività elettrica ad onde alfa rilevata attraverso EEG è stata applicato all’argomento del sogno lucido da LaBerge e Dement [LaBerge, Dement, 1982b]. Questi osservarono quattro soggetti, tutti sognatori lucidi esperti, addestrati a compiere l’attività di cantare ovvero quella di contare durante il sonno REM. Tali attività venivano previamente segnalate attraverso specifici movimenti oculari. Gli autori hanno potuto osservare, e in tal modo confermare l’ipotesi di ricerca: in corrispondenza dell’attività di contare l’emisfero sinistro era più attivo del destro (presentando un minore livello di onde alfa), e viceversa per l’attività di cantare. Inoltre tale lateralizzazione di funzionamento cerebrale era presente, negli stessi soggetti, anche durante le stesse attività durante la veglia.
Sogno lucido e attivazione
LaBerge, Levitan e Dement hanno analizzato i correlati fisiologici di 13 soggetti addestrati a segnalare l’acquisizione della consapevolezza nella fase REM attraverso il movimento degli occhi [LaBerge, Levitan, Dement, 1986]. Le misurazioni fisiologiche erano: la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, l’attività elettrodermica e la densità dei movimenti oculari. Gli autori hanno evidenziato che il momento del passaggio alla lucidità è accompagnato da un aumento di tutte le grandezze misurate. Prove identiche di attivazione fisiologica in concomitanza di sogni lucidi segnalati attraverso movimenti oculari sono riportate anche in una ricerca più recente[Brylowski, Levitan, LaBerge 1989]. LaBerge, Levitan e Dement, e altrove LaBerge [1988b], ipotizzano che l’alto grado di funzioni cognitive coinvolte nel sogno lucido richieda una corrispondente attivazione neuronale. Tuttavia va notato che nella ricerca sopra descritta il confronto tra i valori medi delle quattro grandezze rilevate durante i sogni lucidi e i valori medi delle stesse quattro grandezze durante le fasi REM senza sogni lucidi hanno dato luogo a differenze significative solamente in due parametri: ossia vi è un incremento significativo solo per quanto riguarda la densità dei movimenti oculari e l’attività elettrodermica; tale incremento manca nella frequenza respiratoria e nella frequenza cardiaca.
Si potrebbe ipotizzare che l’attivazione fisiologica misurata da LaBerge et al. sia da attribuire alla esecuzione della richiesta sperimentale di segnalare l’acquisita lucidità attraverso i movimenti oculari, piuttosto che alle caratteristiche intrinseche del fenomeno in esame. Quest’ultima ipotesi, inoltre, sarebbe coerente con i dati raccolti attraverso l’osservazione di un soggetto molto abile nella capacità di essere consapevole durante il sonno da Gackenbach, Moorecroft, Alexander, Laberge [1987]. Il soggetto, un assiduo praticante di Meditazione Trascendentale, asseriva di rimanere cosciente per l’intero periodo del sonno e si dimostrò capace di segnalare attraverso movimenti oculari la propria lucidità dalla fase REM, nonché dalle fasi 1 e 2 non-REM. In concomitanza con la segnalazione si verificava un’attivazione fisiologica che, in contrasto con l’ipotesi di LaBerge et al. [1986], in breve tempo tornava al livello di base. In questo caso sembrava, dunque, che l’attivazione fisiologica fosse dovuta al compito della segnalazione oculare più che alle caratteristiche intrinseche del fenomeno studiato.
L’argomento della attivazione del sistema vestibolare è stato studiato da Gackenbach, Snyder, Rokes e Sachau [1986] in una ricerca in cui venne misurata la responsività elettronistagmografica (ENG) di 48 soggetti attraverso una stimolazione calorica (veniva iniettata dell’acqua calda nel canale auditivo esterno). La frequenza dei sogni lucidi dei soggetti veniva stabilita attraverso la somministrazione di un questionario. La responsività del sistema vestibolare era misurata attraverso i tracciati del ENG, che riportava la velocità del nistagmo dei soggetti, e attraverso i resoconti delle esperienze soggettive di vertigine. L’alta velocità nella fase lenta del nistagmo è considerata [McCabe, Ryu, 1979] essere la migliore misura dell’integrità funzionale del sistema vestibolare. Poiché i risultati della ricerca indicavano una maggiore velocità della fase lenta del nistagmo nei soggetti frequentemente lucidi, Gackenbach et al. hanno proposto che i sognatori frequentemente lucidi presentino una intensa attivazione del sistema vestibolare durante il sonno e che la specifica attività mentale del sogno lucido rifletta tale attivazione.
La relazione tra sistema vestibolare e sogno lucido, è stata osservata in un altro studio in cui è stata evidenziata una correlazione positiva tra la stimolazione del sistema vestibolare e la frequenza dei sogni lucidi [Leslie, Olgivie, 1996]. E’ stato osservato che i soggetti posti a dormire su una amaca oscillante, e quindi in una condizione stimolante il sistema vestibolare, riportavano un incremento nella frequenza dei sogni lucidi.
Va notato che in questo caso gli autori, sebbene abbiano tentato di utilizzare la suddetta metodologia della comunicazione volontaria attraverso i movimenti oculari, non hanno in questo modo raccolto dati attendibili. Gli autori riferiscono che la comunicazione attraverso i movimenti oculari sia stata tentata solamente poche volte (4) dai soggetti e che i relativi tracciati polisonnografici siano confusi e non interpretabili. Gli autori ipotizzano che ciò possa essere attribuito al fatto di aver utilizzato sognatori lucidi non esperti nel compito della segnalazione attraverso i movimenti oculari. In questo caso, dunque, i dati circa la presenza dei sogni lucidi sono stati raccolti attraverso i resoconti dei soggetti.
Equilibrio fisico
Come sopra riportato Gackenbach, Snyder, Rokes e Sachau [1986] hanno verificato la maggiore responsività nistagmografica dei sognatori lucidi alla stimolazione calorica delle membrane del timpano. Esssendo tale responsività nistagmografica considerata [McCabe, Ryu, 1979] essere la migliore misura dell’integrità funzionale del sistema vestibolare, gli autori ipotizzano che una maggiore attività vestibolare abbia luogo durante il fenomeno stesso del sogno lucido. Come è noto il sistema vestibolare svolge un ruolo essenziale nell’orientamento e nell’equilibrio fisico. Coerentemente con la suddetta ipotesi è stata rilevata una maggiore capacità di equilibrio tra i sognatori frequentemente lucidi. In particolare è stato osservato [Gackenbach, Snyder, Rokes, Sachau, 1986; Snyder, Gackenbach, 1988] che i sognatori frequentemente lucidi sono in grado di rimanere in equilibrio su uno stabilometro più a lungo che i sognatori non frequentemente lucidi e dei sognatori non lucidi (in questo caso la frequenza dei sogni lucidi è stata determinata a partire dai resoconti dei soggetti circa la propria vita onirica). Questa forma di equilibrio è chiamata equilibrio statico. Per quanto riguarda l’equilibrio dinamico, misurato camminando su un’asse di equilibrio, non è emersa nessuna differenza significativa tra classi di sognatori.
Psicofisiologia del sonno REM
La possibilità di lavorare in laboratorio con soggetti, talvolta, consapevoli durante le fasi REM, permette di allargare le conoscenze psicofisiologiche del sonno REM, ossia la fase del "sonno paradosso". Essendo lo studio psicofisiologico caratterizzato da variabili indipendenti di tipo psicologico e da variabili dipendenti di tipo fisiologico (e l’EEG ne è lo strumento principale), risulta evidente quanto maggiori siano le possibilità di ricerca nel campo del sonno REM potendo disporre di sognatori lucidi. Questi infatti sembrerebbero [LaBerge, Nagel, Dement, Zarcone, 1981] poter essere preventivamente addestrati a mettere in atto durante il sogno lucido determinati comportamenti (le variabili indipendenti), dando la possibilità allo sperimentatore di osservare i concomitanti fenomeni di ordine fisiologico (le variabili dipendenti).
Attraverso la metodologia dei sogni lucidi ocularmente segnalati LaBerge [1980a; 1985] ha potuto verificare la corrispondenza temporale tra sogno e realtà chiedendo ai suoi soggetti di stimare vari intervalli di tempo. I segnali dei soggetti prodotti prima e dopo gli intervalli di tempo stimati hanno permesso il confronto con il tempo oggettivo. Secondo l’autore i soggetti erano in grado di stimare gli intervalli di tempo durante il sogno lucido con un livello di imprecisione moderato e, comunque, simile a quello mostrato dagli stessi soggetti nello stesso compito durante la veglia.
In una ricerca [Fenwick, Schatzman, Worsley, Adams, Stone, Baker, 1984] che si proponeva di rilevare le eventuali corrispondenze tra eventi sognati ed eventi reali vennero prese misurazioni elettromiografiche di numerosi gruppi muscolari di un sognatore lucido esperto nel compito della segnalazione attraverso i movimenti oculari. Gli autori sono giunti a varie conclusioni. Innanzi tutto sembrerebbe che l’atonia muscolare della fase REM abbia un gradiente variabile, essendo presente maggiormente nella muscolatura assiale, e in misura minore nella muscolatura distale: sono stati misurati piccolissimi movimenti delle dita delle mani, delle dita dei piedi e dei piedi stessi. L’inibizione motoria colpirebbe maggiormente i muscoli estensori rispetto ai flessori. Emergerebbe una precisa corrispondenza tra il corpo sognato e il corpo fisico: i movimenti del primo provocherebbero corrispondenti contrazioni nei gruppi muscolari del secondo, seppure in misura attenuata e secondo le caratteristiche anzi esposte.
Sono state compiute osservazioni psicofisiologiche dei sogni lucidi a contenuto erotico di un soggetto di genere femminile [LaBerge, Greenleaf, Kadzierski, 1983]. I dati fisiologici comprendevano: l’EEG, l’EOG, la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca, la conduttanza dermica, l’EMG vaginale e l’ampiezza delle pulsazioni vaginali. Fu possibile analizzare i dati fisiologici corrispondenti alle varie fasi dell’attività erotica onirica del soggetto, poiché questi era in grado di segnalarle attraverso specifici movimenti oculari. La frequenza respiratoria, la conduttanza dermica, l’EMG vaginale e l’ampiezza delle pulsazioni vaginali, rilevati durante l’orgasmo, mostravano un generale aumento rispetto ai valori medi delle altre fasi REM. Contrariamente alle aspettative, invece, la frequenza cardiaca non mostrava un aumento significativo.
LaBerge ha replicato questo esperimento [LaBerge, 1985] con due soggetti di genere maschile. Anche in questo caso la frequenza respiratoria aumentò significativamente, mentre la frequenza cardiaca rimase stabile. Bisogna notare, inoltre, che entrambi i soggetti, pur raggiungendo l’orgasmo nei propri sogni lucidi, non eiacularono.
LaBerge [1988b] ha proposto che i risultati della ricerca psicofisiologica sul sogno lucido suggeriscano conclusioni valide anche per la psicofisiologia del sonno REM in genere. Gli eventi che noi immaginiamo di sperimentare durante i sogni sarebbero il risultato di una attività cerebrale che produrrebbe effetti sul corpo simili a quelli che avrebbero luogo se sperimentassimo gli stessi eventi nello stato di veglia. E questo perché, come è stato sostenuto da Finke [1980] l’immaginazione multimodale del sogno sarebbe prodotta dagli stessi sistemi cerebrali che producono le percezioni equivalenti del mondo reale. LaBerge ha sostenuto [ibidem] che questo potrebbe spiegare anche perché generalmente noi scambiamo i nostri sogni per realtà: perché per i sistemi funzionali cerebrali che costruiscono il nostro mondo esperienziale sognare di percepire qualcosa o farlo realmente sarebbero la stessa cosa.
Caratteristiche psicologiche dei sognatori lucidi
Incidenza e frequenza
Per un discorso della psicologia delle differenze individuali in relazione ai sogni lucidi occorre innanzi tutto comprendere le dimensioni del fenomeno. Gli studi a proposito riportano dati relativamente variabili in relazione a due problemi. Il primo riguarda le procedure di campionamento. I dati circa la diffusione del fenomeno variano a seconda che il campione studiato sia composto da soggetti individuati casualmente, da adulti interessati all’argomento o ai sogni in genere, o da studenti universitari. Generalmente è stata trovata una più ampia diffusione tra i soggetti che hanno un interesse nella sfera dei sogni precedente al campionamento. Ovviamente offrono dati migliori, o meglio più generalizzabili, gli studi compiuti su campioni casuali.
Il secondo problema riguarda la verifica della comprensione dell’oggetto di studio da parte dei soggetti della ricerca. Questo è il caso di quegli studi che si basano su dati raccolti attraverso questionari, scale, diari o autodescrizioni in genere, e non su dati di laboratorio secondo la metodologia della comunicazione volontaria durante il sonno REM. L’utilizzo del laboratorio del sonno, che permetterebbe una verifica empirica dell’accadere del fenomeno, è limitato ad un numero esiguo di soggetti, quindi le ricerche miranti a determinare la frequenza e l’incidenza del fenomeno, dovendo utilizzare campioni relativamente numerosi, si sono avvalse delle procedure di raccolta dei dati basate sulle risposte date dai soggetti a questionari e scale o sulle loro autodescrizioni riportate in diari personali. E’ stato evidenziato [Snyder, Gackenbach, 1988] che spesso le persone fraintendono la natura del sogno lucido, scambiandola con la capacità di ricordare i sogni ordinari. Per questo motivo, nel caso dei dati raccolti fuori dal laboratorio, occorre effettuare una preventiva verifica della comprensione del concetto in esame da parte dei soggetti.
L’incidenza del sogno lucido misura il tasso percentuale degli individui che hanno avuto almeno una esperienza nella loro vita. Una stima dell’incidenza, effettuata su un campione casuale e attraverso la verifica della comprensione del concetto di sogno lucido, è pari al 57.5% [Gackenbach, Snyder, Roches, Sachau, 1986]. Altre stime dell’incidenza variano dal 100% [Gackenbach, Curren, LaBerge, Davidson, Maxwell, 1983], stima ottenuta su un campione di soggetti adulti altamente motivati e manifestamente interessati alla vita onirica, al 47% [Blackmore, 1983]. Quest’ultima stima si riferisce ad uno studio effettuato su un campione casuale ma senza la verifica delle presunte dichiarazioni di lucidità.
La frequenza di sogni lucidi nei singoli individui varia da un limite in cui il fenomeno non si presenta affatto al limite, non chiaramente definito, in cui il sognatore ha numerose esperienze al mese. LaBerge [1980a] riporta di aver raggiunto, applicando la MILD, la tecnica di induzione da lui sviluppata, una media di 21.5 sogni lucidi al mese, con un massimo di quattro per notte.
Gackenbach [1978] ha classificato i soggetti in base alla frequenza delle esperienze di lucidità in: sognatori frequentemente lucidi ("frequent lucid dreamers"), che hanno una o più esperienze di sogno lucido al mese; sognatori non frequentemente lucidi ("infrequent lucid dreamers"), che hanno sperimentato il fenomeno una o più volte nella loro vita, ma meno di una volta al mese; sognatori non lucidi ("nonlucid dreamers"), che non hanno mai avuto esperienze di sogno lucido. Come precedentemente riportato, la stima dell’incidenza, calcolata su un campione casuale e attraverso la verifica della comprensione, è pari a 57.5%. Tale percentuale comprende tutti i sognatori lucidi, sia quelli frequentemente lucidi che quelli non frequentemente lucidi. Le stime dell’incidenza dei sognatori frequentemente lucidi variano da un minimo di 15% [Ibidem], ad un massimo di 28.5% [Palmer, 1974].
Non sono state rilevate differenze tra i generi quanto a incidenza e frequenza del fenomeno [Blackmore, 1982; Gackenbach, 1978, 1985; Gackenbach, Curren, LaBerge, Davidson, Maxvell, 1983; Hearne, 1978].
L’età sembra essere un fattore determinante nella frequenza. Diversi studi [Blackmore, 1983; Kueny, 1985; Palmer, 1974] hanno evidenziato come i soggetti più giovani abbiano sogni lucidi più spesso di quelli più anziani. Tuttavia, per quanto riguarda i soggetti di genere femminile, in una ricerca [Gackenbach, 1978] questa relazione è stata anche descritta in termini opposti: fra le donne, con un manifesto interesse per l’attività onirica in generale, le più anziane hanno riportato una maggiore frequenza di lucidità che le più giovani.
Altri fattori che hanno mostrato di essere in relazione con una maggiore frequenza dei sogni lucidi sono l’ordine di nascita e lo stato civile [Gackenbach, Curren, LaBerge, Davidson, Maxvell, 1983]: i primogeniti e gli individui non sposati hanno mostrato di avere più sogni lucidi dei fratelli minori e degli individui sposati.
Nello studio di Palmer del 1974 su una popolazione statunitense e, in particolare, dello stato del Virginia, i soggetti di colore hanno mostrato una maggiore incidenza dei soggetti bianchi, riportando una percentuale pari al 76% della popolazione a fronte del 53% rilevato nei secondi. Nello stesso studio emerge, invece, che la variabile del reddito non influenza la grandezza del fenomeno.
Indipendenza dal campo
E’ stata evidenziata una relazione stabile tra frequenza di sogni lucidi e indipendenza dal campo [Gackenbach, Heilman, Boyt, LaBerge, 1985], nell’ambito del costrutto di "campo-indipendenza/campo-dipendenza". L’elaborazione di Witkin, svoltasi inizialmente nell’ambito dell’indagine sperimentale sulla percezione della verticale, ha riguardato anche una teorizzazione dei processi cognitivi attraverso il costrutto della "differenziazione psicologica". La constatazione della stabilità nell’utilizzo di informazioni o interne o esterne nella percezione della verticale, ha portato Witkin ha ipotizzare conseguenti caratteristiche di stabilità nei processi cognitivi decisori nei termini di una maggiore o minore tendenza a privilegiare le proprie intime convinzioni. Secondo questi costrutti l’individuo che nella percezione della verticale si affida alle proprie informazioni interne provenienti dal sistema vestibolare e dai sensi cinestetico e tattile piuttosto che alle informazioni esterne percepite attraverso il senso della vista, dunque l’individuo "indipendente dal campo", presenta una maggiore "differenziazione psicologica" e, quindi, uno stile cognitivo di problem-solving legato maggiormente alle proprie convinzioni e informazioni, un Sé ben differenziato rispetto al non-Sé.
Numerose ricerche hanno associato al fatto di percepire in modo dipendente o indipendente dal campo diverse caratteristiche che riflettono il livello di differenziazione psicologica della persona. Le caratteristiche studiate appartengono a discipline estremamente diverse: in ambito evolutivo si è parlato di differenziazione e di integrazione; in ambito psicodinamico di controlli e difese; nell’ambito della psicologia sociale di condotte pro-sociali e anti-sociali; in ambito biologico del livello degli ormoni sessuali; in ambito antropologico di cultura nomade e stanziale. Data la varietà delle discipline coinvolte, nonché la notevole quantità degli studi, la correlazione individuata tra dipendenza/indipendenza dal campo e sogno lucido ha un valore euristico nell’individuare ambiti di ricerca e ipotesi per quanto riguarda il secondo. Infatti alcuni studi sul sogno lucido (di seguito riportati), di pertinenza della psicologia delle differenze individuali, sono stati effettivamente influenzati dalla sua relazione con le scoperte di Witkin.
Intelligenza e creatività
I primi studi sulla dipendenza dal campo e il funzionamento intellettuale [Witkin, Goodenough, Oltman, 1979] sostenevano una corrispondenza tra l’indipendenza dal campo e una superiorità intellettiva per quanto riguarda le facoltà di tipo visuo-spaziale. Alla luce di questi dati e della relazione tra indipendenza dal campo e frequenza dei sogni lucidi, Snyder e Gackenbach [1988] hanno ipotizzato che i sognatori lucidi presentino punteggi più alti nelle prove di intelligenza non verbale. Gli stessi autori sostengono, però, che la loro ipotesi necessiti di ulteriori conferme da parte delle indagini future, dal momento che le indagini passate presentano risultati poco affidabili e contraddittori. Ad esempio Hearne [1978] e Gackenbach, Snyder, McKelvey, McWilliams, George, Rodenelli [1981] non hanno trovato differenze tra i sognatori attraverso prove di problem-solving basate sulle capacità visive.
Gackenbach, Curren, LaBerge, Davidson, Maxwell [1983] hanno rilevato che i sognatori lucidi di sesso femminile presentavano punteggi superiori ai soggetti che non avevano sogni lucidi nelle prove di abilità numerica e verbale, misurate dalle sotto-scale del Comprehensive Abilities Battery [Hakstain, Cattell, 1975]. I soggetti di genere maschile presentavano un andamento opposto, riportando i sognatori lucidi punteggi inferiori nelle suddette prove. Va notato che quest’ultimo studio non possiede una sufficiente validità esterna essendosi basato sulle dichiarazioni, raccolte per posta, di soggetti autoselezionatisi.
La creatività verbale e non verbale sono state misurate [Gackenbach, Hammons, 1983; Gackenbach, Curren, LaBerge, Davidson, Maxwell, 1983] attraverso il Remote Association Test e il Torrance Tests of Creative Thinking. Le donne che avevano sogni lucidi hanno riportato maggiori punteggi sia per la creatività verbale che per quella non verbale, rispetto alle donne che non avevano questa esperienza. Negli uomini non sono state trovate differenze significative per tipi di sognatori. Si attendono i risultati della ricerca futura.
Mascolinità e femminilità
La mascolinità e la femminilità di una persona sono determinate dalla misura in cui questa mostra di possedere caratteristiche tipicamente evidenziate negli uomini o nelle donne di una data cultura. Ad esempio alcune caratteristiche tipicamente attribuite agli uomini della nostra cultura sono: la maggiore indipendenza dal campo, la minore attenzione agli stimoli sociali, un locus of control maggiormente interno rispetto alle donne.
Gackenbach, Curren, LaBerge, Davidson e Maxwell [1983] hanno somministrato il Personal Attributes Questionnaire [Spence, Helmreich, 1978] a soggetti adulti con un manifesto interesse nella vita onirica. I risultati mostrarono che il fattore mascolinità era direttamente proporzionale alla frequenza dei sogni lucidi in modo statisticamente significativo negli uomini, e in modo non statisticamente significativo nelle donne. Il fattore femminilità era correlato positivamente con la frequenza dei sogni lucidi solamente negli uomini.
Un’altra ricerca [Kueny, 1985] ha indagato lo stesso ambito attraverso il CPI, il California Psychological Inventory, utilizzandone la sotto-scala della femminilità. Questo studio ha rilevato una relazione positiva tra femminilità e frequenza dei sogni lucidi (frequenza verificata in laboratorio attraverso i movimenti oculari).
La propensione al rischio, una caratteristica attribuita agli uomini, è stata studiata in relazione al sogno lucido nella menzionata ricerca di Gackenbach, Curren, LaBerge, Davidson e Maxwell [1983]: la propensione al rischio è risultata essere correlata positivamente con la frequenza dei sogni lucidi solamente nelle donne.
Snyder e Gackenbach [1988], alla luce di queste ricerche, propongono che entrambi i fattori, mascolinità e femminilità, siano collegati al fenomeno del sogno lucido e suggeriscono che i sognatori frequentemente lucidi tendano verso un’identità di genere di tipo androgino.
Estroversione, introversione e suscettibilità all’ansia
A partire dalla relazione evidenziata tra frequenza dei sogni lucidi e indipendenza dal campo Snyder e Gackenbach [1988] ipotizzano che i sognatori frequentemente lucidi abbiano un orientamento intrapersonale piuttosto che interpersonale, che tendano verso l’introversione piuttosto che verso l’estroversione. Data la suddetta tendenza alla introversione e la ormai assodata relazione tra introversione e attivazione fisiologica [Eysenck, 1982], gli autori ipotizzano, inoltre, che i sognatori frequentemente lucidi presentino anche un più elevato livello di attivazione fisiologica e di suscettibilità all’ansia. Secondo gli autori, dunque, i sognatori frequentemente lucidi presenterebbero un orientamente intrapersonale e un’alta suscettibilità all’ansia.
E’ stata evidenziata una corrispondenza tra ansietà e frequenza di sogni lucidi solamente negli uomini, mentre nelle donne è stata rilevata la relazione inversa [Snyder, Gackenbach, 1988]. Questo dato, come notano gli autori stessi, rispetto alla suddetta ipotesi, è ambiguo. L’argomento merita un approfondimento da parte di studi futuri.
Né la stessa ipotesi, ossia che i sognatori frequentemente lucidi presentino un orientamento intrapersonale, sembra essere stata suffragata da ricerche che hanno approfondito la relazione tra sogno lucido e estroversione/introverssione.
Alcune ricerche sull’argomento hanno utilizzato il Self-Consciousness Inventory (SCI) [Fenigstein, Scheier, Buss, 1975]. Tale test misura la tendenza delle persone ad essere "auto-consapevoli" in due ambiti: l’auto-consapevolezza privata e l’auto-consapevolezza pubblica. La prima sarebbe la tendenza abituale ad essere consapevoli dei propri pensieri, motivazioni e sentimenti e, quindi l’orientamento intrapersonale, mentre la seconda riguarderebbe l’attenzione alla proprio modo di apparire in un contesto sociale, alle impressioni suscitate negli altri, e quindi l’orientamento interpersonale. In una ricerca di Gackenbach e LaBerge del 1982 [riportata in: Snyder, Gackenbach, 1988], gli autori somministrarono il Self-Consciousness Inventory ad una classe di studenti riportando una correlazione positiva tra auto-consapevolezza privata e frequenza di sogni lucidi. Risultati opposti ha ottenuto Kueny [1985] che ha utilizzato il SCI con dei soggetti adulti, trovando una relazione inversa tra auto-consapevolezza privata e frequenza di sogni lucidi.
Mentre Hearne [1978] ha somministrando ai suoi soggetti l’Eysenck Personality Inventory (EPI), non ha trovato una differenza tra sognatori lucidi e sognatori non lucidi per la scala dell’estroversione.
Controllo e benessere
Il costrutto di locus of control interno/esterno tende a descrivere la misura in cui la persona si percepisce come la sorgente causale degli eventi della propria vita e si rispecchia nella motivazione al controllo degli stessi. Questo costrutto è stato associato da Rotter [1966] con quello della indipendenza/dipendenza dal campo. E’ stata verificata la relazione positiva tra frequenza dei sogni lucidi e indipendenza dal campo [Gackenbach, Heilman, Boyt, LaBerge, 1985]. Ci si aspetta, dunque, una correlazione positiva anche tra frequenza dei sogni lucidi e locus of control interno. Questa relazione è stata verificata nello studio di Blagrove e Tucker [1994]
Coerentemente con i dati sopra riportati e riguardanti la relazione tra locus of control e sogno lucido, Prescott e Pettigrew [1995] hanno rilevato come il livello di controllo sulle situazioni della vita della veglia sia positivamente correlato con la frequenza dei sogni lucidi. Gli autori, data l’esiguità del campione, 17 soggetti, suggeriscono che il loro studio abbia il valore di ricerca preliminare. Ed ancora, è stato notato che i sognatori frequentemente lucidi dimostrano una maggiore volontà di gestire i processi cognitivi ed emotivi rispetto ai sognatori non frequentemente lucidi [Gruber, Steffen, Vonderhaar, 1995].
Sembra, dunque, che i sognatori frequentemente lucidi siano molto motivati a controllare gli eventi della vita della veglia.
Questi dati acquistano un ulteriore senso esplicativo se vengono associati con l’alta capacità dei sognatori lucidi di ricordare i sogni ordinari [Gackenbach, 1988;Wolpin, Marston, Randolph, Clothier, 1992]. Sembrerebbe, dunque, che i sognatori frequentemente lucidi siano altamente interessati a gestire la propria vita in toto, ponendo attenzione agli aspetti di essa sia per quanto riguarda la veglia che il sonno.
Un’altra relazione interessante è stata evidenziata da Wolpin, Marston, Randolph, Clothier [1992]. Gli autori hanno rilevato una correlazione positiva tra benessere percepito soggettivamente e frequenza dei sogni lucidi.
Si attendono ulteriori ricerche che chiariscano da un lato la relazione tra sogno lucido e benessere percepito, dall’altro i legami tra benessere percepito e capacità di controllo sugli eventi della vita della veglia e della vita onirica.
Tecniche di induzione del sogno lucido
Il sogno lucido talora si presenta spontaneamente. Tuttavia LaBerge sostiene che solo un individuo su dieci sia un sognatore lucido "naturale" [Hooper, Teresi, 1986, p.338]. Le cifre delle stime dell’incidenza dei sognatori frequentemente lucidi, variano da un minimo di 15% [Gackenbach, 1978], ad un massimo di 28.5% [Palmer, 1974]. Esistono, però, diverse tecniche di induzione sviluppate da diversi autori, nelle diverse culture e nelle diverse epoche. In un articolo che analizza queste tecniche Robert F. Price e David B. Cohen [1988, p.131] concludono che la possibilità di sperimentare il sogno lucido sia aperta agli individui molto motivati a vivere quest’esperienza. Naturalmente, come per tutte le capacità, la facilità e i tempi differirebbero da individuo a individuo.
Un primo rilievo riguarda la motivazione: nelle tecniche descritte qui di seguito la motivazione sembra essere una condizione necessaria. Come dire: per avere un sogno lucido, innanzi tutto, bisogna desiderarlo. Purtroppo la motivazione non è qualcosa che possa essere appresa attraverso una tecnica o un esercizio. Può essere presente in diversi gradi nelle diverse persone o nei diversi momenti, tuttavia c’è o non c’è, e , nel secondo caso, non può essere trasmessa attraverso una procedura. Una osservazione interessante riguarda la pratica della meditazione. Nei soggetti che meditano abitualmente, anche se non ricercano l’esperienza del sogno lucido, questa sembra comparire come effetto secondario [Reed, 1977]. In questo caso, dunque, la fenomenologia del sogno lucido appare in seguito ad una specifica pratica, ma in assenza di una motivazione diretta.
Il secondo rilievo riguarda la consapevolezza degli stati di coscienza. Gran parte delle seguenti tecniche coinvolgono l’individuo in un lavoro sul proprio stato di coscienza: questi impara a chiedersi in quale stato di coscienza si trova nel momento attuale, se sta sognando o no, e gradualmente sviluppa un’attitudine critica circa la propria vita mentale. L’obiettivo di sviluppare questa capacità discriminatoria può essere perseguito direttamente, ad esempio mediante l’esercizio di porsi il quesito circa il proprio stato di coscienza varie volte al giorno, ovvero può essere ottenuto indirettamente, attraverso visualizzazioni o ripetizioni di frasi del tipo: "Il prossimo sogno che avrò sarà un sogno lucido". Ad esempio nella tecnica MILD il soggetto si esercita a visualizzare sogni realmente avuti in precedenza, divenendo via via sempre più consapevole, ossia pronto a cogliere la diversità dei due stati di coscienza: la veglia e il sogno.
Questo stato di vigilanza, di "presenza di spirito" o di "aumentata consapevolezza", la prontezza, dunque, nel discriminare un sogno dalla veglia rappresenta il trampolino di lancio verso l’esperienza del sogno lucido, ne è la condizione sufficiente. Le diverse tecniche tentano di promuovere questa condizione durante la fase REM del sonno, e lo fanno secondo metodologie diverse. Così la suggestione post-ipnotica mira a far sorgere questa capacità discriminatoria durante la fase del "sonno paradosso" per mezzo della suggestione dell’ipnotista. Anche le tecniche che utilizzano segnali tattili, uditivi o visivi per "ricordare" al sognatore che sta sognando, promuovono il suddetto "aumento di consapevolezza", questa volta attraverso apparecchiature automatizzate che riconoscono la fase REM e segnalano questa informazione al dormiente. Altre tecniche propongono una serie di esercizi per incrementare la suddetta capacità discriminatoria nello stato di veglia, nell’ipotesi che venga conservata anche mentre ha luogo il sogno. Questa ipotesi riguarda la maggior parte delle tecniche conosciute, come ad esempio: la MILD, la FAST, la tecnica di Castaneda e quelle di Tholey.
La meditazione merita una considerazione a sé. La meditazione, o per lo meno una larga parte delle pratiche che si celano dietro questo nome, mira a sviluppare la consapevolezza dei propri contenuti mentali e quindi del proprio stato di coscienza, condizione sufficiente, come si è visto, affinché l’esperienza del sogno lucido abbia luogo. Il sogno lucido, che rappresenta un effetto secondario non direttamente ricercato della meditazione, si manifesterebbe, in questo caso, solamente in un secondo momento e nel lungo periodo.
Il sogno lucido può avere inizio a partire dallo stato di sonno, dallo stato ipnotico e dallo stato di veglia. La descrizione delle diverse tecniche seguirà questo ordine:
Tecniche di induzione del sogno lucido con inizio durante il sonno
Tecniche di induzione del sogno lucido a partire dallo stato ipnotico
Tecniche di induzione del sogno lucido a partire dallo stato di veglia
Tecniche per prolungare il sogno lucido
E’ stata spesso sottolineata la fugacità con la quale il sogno lucido appare ed ha fine. Le emozioni intense sembrano por fine all’esperienza, quindi viene spesso raccomandato di controllarsi e di mantenersi il più possibili calmi e padroni di se stessi. Nonostante queste generiche raccomandazioni, le esperienze possono continuare ad essere estremamente brevi.
E’ stato soggettivamente notato dalla maggioranza dei sognatori lucidi che il momento in cui la consapevolezza di star sognando comincia a svanire sia spesso chiaramente distinguibile. Lo sforzo per mantenere tale consapevolezza, quindi, per prolungare l’esperienza del sogno lucido, è paragonabile allo sforzo che si fa per restare svegli dopo un periodo di deprivazione del sonno. Al fine di tentare di allungare la durata del sogno lucido, a vantaggio sia del ricercatore che del sognatore, diversi autori hanno proposto delle tecniche che il sognatore deve mettere in atto quando sente che il sogno lucido sta per finire.
Tali tecniche, per lo più, consistono nel focalizzare l’attenzione del sognatore su un elemento del sogno. Moers-Messmer, nel 1938, consigliava di portare l’attenzione sul pavimento al fine di stabilizzare il sogno lucido.
Sempre a tal fine, Sparrow [1972] sosteneva che fosse necessario focalizzare l’attenzione su un qualsiasi elemento del sogno dotato di stabilità. Il corpo del sognatore, rimanendo sufficientemente stabile durante i sogni lucidi, si presterebbe ottimamente ad essere oggetto di tale attenzione. L’autore suggeriva, quindi, di osservare una parte del proprio corpo, come ad esempio le mani. Oppure un altro oggetto utile su cui focalizzare l’attenzione e che si mantiene relativamente stabile potrebbe essere il pavimento vicino ai propri piedi.
LaBerge [1995] ha confrontato tre tecniche che possono essere messe in atto allorché il sognatore lucido si rende conto che la lucidità lo sta abbandonando. Le tre tecniche sono state proposte ad un gruppo di sognatori lucidi esperti che le hanno sperimentate per proprio conto e, in seguito, hanno riferito i risultati. Esse sono:
"Spinning": consiste nel ruotare su se stessi il più velocemente possibile a partire dalla posizione verticale e con le braccia divaricate. Occorre avvertire intensamente la sensazione fisica della rotazione. Mentre compie il movimento il sognatore si ripete: "La prossima scena sarà un sogno."
Quando il sognatore si rende conto che sta perdendo la consapevolezza di star sognando, ignora tale sensazione e continua a fare ciò che stava facendo. Mentre continua l’attività precedente ripete a se stesso: "La prossima scena sarà un sogno."
Il sognatore si strofina le mani con vigore. E’ importante percepire vivamente la frizione prodotta dallo sfregamento delle mani. Mentre compie il movimento il sognatore si ripete: "La prossima scena sarà un sogno."
LaBerge ha rilevato che le tecniche dello "spinning" e dello strofinarsi le mani sono particolarmente efficaci nel prolungare i sogni lucidi. L’esperienza è stata prolungata nel 96% dei casi con lo "spinning", mentre è stata prolungata nel 90% dei casi attraverso la tecnica dello strofinamento delle mani. I sogni lucidi di coloro i quali, avvertendo la fine della lucidità, hanno ignorato tale sensazione e hanno mantenuto l’attività precedente, sono continuati nel 33% dei casi. L’autore suggerisce anche che la tecnica dello "spinning" possa essere utilizzata per produrre le transizioni da una scena del sogno ad un’altra. La tecnica avrebbe la doppia valenza di prolungare il sogno lucido e di aumentare la capacità di controllo dell’esperienza stessa da parte del sognatore.
Applicazioni cliniche e terapeutiche
In questo capitolo saranno riportate le esperienze di alcuni autori che, negli ultimi anni, hanno utilizzato lo strumento del sogno lucido nella loro attività terapeutica. L’utilizzo dello strumento del sogno lucido in clinica è molto recente, come è recente il fiorire dell’interesse nei confronti del suddetto argomento. Gli autori propongono una molteplicità di applicazioni e obiettivi terapeutici diversi. Garfield [1988], in una recensione della letteratura sull’argomento, ha individuato dieci diverse aree di intervento. I sogni lucidi permetterebbero di:
Sviluppare una maggiore auto-consapevolezza, sia nei confronti della vita della veglia che della vita onirica.
Liberarsi dagli incubi.
Risolvere problemi.
Sperimentare azioni alternative senza timore delle conseguenze; sviluppare la capacità auto-assertiva intraprendendo azioni deliberate.
Accelerare l’attività del sistema immunitario.
Aumentare la capacità di cambiare la vita della veglia.
Sviluppare elementi nuovi nella propria personalità; comprendersi meglio.
Integrare gli aspetti conflittuali del Sé; integrare la personalità.
Esplorare le potenzialità creative della mente.
Differenziare più chiaramente la veglia dalla vita onirica.
Le potenzialità di applicazione dello strumento in esame sembrano essere molto ampie. Gli autori hanno proposto interventi terapeutici diversi secondo gli obiettivi propostisi. Va notato, tuttavia, come le proposte nel loro insieme tendano ad una responsabilizzazione del paziente nel processo di guarigione e di crescita psicologica. Questo è, a ben vedere, una inevitabile conseguenza dell’uso di uno strumento che, per sua natura, richiede una elevata attenzione ai propri processi mentali, sia della veglia sia del sonno/sogno. Le proposte sembrano condurre ad una crescita psicologica che passa attraverso uno sforzo continuo nel tempo: il paziente, in un trattamento che utilizzi il sogno lucido, si impegna continuamente. Il suo impegno, infatti, si estende durante il rapporto con il terapeuta, a casa mentre applica le tecniche suggeritegli (che spesso lo coinvolgono nell’interezza della sua vita di veglia, come ad esempio nel caso del compito che consiste nel chiedersi frequentemente: "Questo è un sogno?"), prima di addormentarsi e, naturalmente, durante il sonno.
Ci si potrebbe chiedere se lo sforzo richiesto sia giustificato dai risultati raggiungibili. Ovvero ci si potrebbe chiedere quali sono le prove empiriche del successo clinico della terapia o auto-terapia che utilizza questo strumento. Purtroppo i tempi non sono ancora maturi per dare una risposta definitiva a nessuna delle due domande. Ci rimangono solamente le testimonianze degli autori che negli ultimi anni hanno utilizzato il sogno lucido nel proprio lavoro di terapista, scommettendo sulla sua efficacia. Tali testimonianze sembrano essere interessanti, ossia degne d’approfondimento.
Il trattamento del disturbo da incubi: Brylowski
L’utilizzo clinico dello strumento del sogno clinico maggiormente descritto in letteratura riguarda il trattamento del disturbo da incubi. Brylowski [1990] ha descritto il caso di un soggetto con una diagnosi di disturbo borderline di personalità, depressione maggiore e disturbo da incubi. In seguito ad un trattamento che si focalizzava prevalentemente sull’uso del sogno lucido, la paziente fu alleviata dai suoi sintomi, riducendosi gli incubi in termini di intensità e di frequenza.
L’autore ha notato che i benefici risultanti dal trattamento si estendevano oltre la sfera del sonno: la paziente sembrava aver sviluppato un Io più forte ed aver goduto di un generale aumento del senso del benessere personale. Da ciò inferisce che il sogno lucido possa essere uno strumento utile sia nel campo del disturbo da incubi, che nell’ambito più allargato della psicoterapia. L’autore stesso sottolinea la necessità di un maggiore impegno nel campo della ricerca al fine di verificare le proprie ipotesi.
Diversi autori, successivamente al citato articolo di Brylowski, hanno portato conferme al valore terapeutico dell’induzione del sogno lucido al fine di alleviare il disturbo da incubi. Tra questi: Evers e Van de Wetering [1993]; Abramovitch [1995], che ha descritto il caso di un successo radicale; Zadra [1996] nell’ambito del trattamento degli incubi ricorrenti in età adulta; Zadra e Phil [1997], che si chiedono se il fattore di successo risieda nella capacità di avere sogni lucidi in sé, ovvero risieda nell’abilità di modificare a piacimento gli elementi onirici.
Il programma di auto-guarigione e di crescita psicologica di Paul Tholey
Tholey [1988] ha proposto l’utilizzo del sogno lucido come strumento di diagnosi e di risoluzione dei conflitti inconsci al fine di promuovere la crescita psicologica. Il suo programma di auto-guarigione consta di quattro punti:
Le tecniche per indurre i sogni lucidi.
I metodi per influenzare e manipolare il contenuto dei sogni lucidi.
Le indicazioni per gestire le resistenze e i meccanismi di difesa che possono insorgere durante il trattamento dei conflitti.
Una serie di principi-guida per gestire le interazioni con i personaggi del sogno lucido.
Le tecniche per l’induzione del sogno lucido proposte dall’autore [Tholey, 1983] sono descritte altrove in questo scritto. Va notato che l’autore individua l’efficacia terapeutica di questo programma non nella possibilità di avere sogni lucidi, bensì nell’interazione tra sognatore e personaggio del sogno condotta con l’atteggiamento amichevole del sognatore. Dunque divenire consapevoli dei propri sogni è solamente il primo passo.
Il nocciolo di questo approccio terapeutico consiste nel riconciliarsi con personaggi onirici terrorizzanti. Il soggetto che segue questo programma di auto-guarigione cerca attivamente una interazione con personaggi spaventosi all’interno dei propri sogni lucidi. Nel caso non siano presenti elementi di paura il soggetto deve cercare intenzionalmente di produrre all’interno del sogno situazioni e personaggi capaci di spaventarlo. Secondo l’autore ciò è possibile cercando di modificare il sogno lucido nella direzione di situazioni con bassa luminosità, promuovendo contenuti onirici collegati con il passato, ovvero rivolgendo l’attenzione verso il basso rispetto che verso l’alto (ad esempio osservando cosa c’è sul fondo di uno stagno piuttosto che mantenendo l’attenzione sulla superficie di questo).
Una volta ottenuto l’effetto desiderato di avere sogni lucidi a sfondo terrorifico, possono comparire delle resistenze. Queste possono frapporsi al perseguimento di una interazione positiva con i personaggi onirici. Alcune resistenze possono prendere la forma di elementi onirici quali: porte, cancelli, forze invisibili o palizzate, che ostacolano il sognatore. Talvolta la resistenza può manifestarsi attraverso la difficoltà di mantenere la condizione di lucidità, ovvero trasformandosi il sogno lucido in unfalso risveglio, ed impedendo, così, lo svolgersi del programma di auto-guarigione. E ancora le resistenze all’ulteriore trattamento possono prendere la forma di minacce o aggressioni fisiche da parte dei personaggi del sogno. Le diverse forme di resistenza vengono descritte ai soggetti che seguono questo programma. Agli stessi viene raccomandato di cercare di confrontarsi con le situazioni spaventose in modo graduale, affrontando in un primo tempo solo le esperienze poco piacevoli per passare poi a quelle terrorizzanti.
Il fulcro del programma consiste in una serie di principi-guida miranti ad una interazione, con i personaggi delle situazioni oniriche spiacevoli, che sia la più conciliatoria possibile. Tale metodologia permetterebbe, secondo l’autore, sia di individuare la natura del conflitto inconscio a monte delle vicende oniriche spiacevoli, lucide e non lucide, avendo in questo caso una funzione diagnostica, e sia di risolvere tale conflitto in modo definitivo con una funzione chiaramente terapeutica. L’interazione con le figure oniriche spaventose dovrebbe essere perseguita attraverso i seguenti principi:
Confronto: non bisogna fuggire da un personaggio onirico spaventoso, piuttosto bisogna cercare un confronto con esso. Guardandolo apertamente e con tono amichevole gli si può chiedere: "Chi sei?", oppure: "Chi sono io?"
Dialogo: se è possibile comunicare con il personaggio onirico, bisogna cercare di riconciliarsi con esso. Se non è possibile raggiungere un accordo, allora è meglio avere una franca discussione con esso, rifiutandone gli insulti e le minacce, ma accettandone le obiezioni ragionevoli.
Combattere: mai arrendersi ad un attacco da parte del personaggio onirico. Anzi, occorre mostrarsi sempre pronti a difendersi, assumendo una posizione difensiva e guardando il personaggio dritto negli occhi. Se il combattimento è inevitabile, bisogna combattere per vincere, ma non per uccidere. Una volta battuto il personaggio, bisogna offrirgli nuovamente la possibilità di una riconciliazione.
Riconciliazione: questa deve avvenire attraverso le parole, i pensieri e i gesti.
Separazione: se la riconciliazione è impossibile ci si separa. La separazione ha luogo attraverso le parole, i pensieri e l’allontanamento fisico dal personaggio onirico. Qualche volta occorre separarsi da un personaggio con cui ci si è riconciliati, quando questo rappresenti una persona morta o comunque non più presente nella vita del soggetto. In questi casi, prima di allontanarsi dal personaggio, si ringrazia per l’aiuto dato in passato.
Cercare aiuto: Se è stata raggiunta la riconciliazione, il sognatore può chiedere aiuto al personaggio, non più ostile, circa i propri problemi della vita della veglia ovvero della vita onirica.
Tholey ha notato che se l’interazione viene condotta con un atteggiamento conciliatorio spesso si produce una trasformazione nella figura ostile stessa: un mostro, una figura mitologica o una animale possono trasformarsi in una figura umana (ad esempio il padre o la madre del sognatore). Al contrario un atteggiamento aggressivo in risposta ad un attacco produce l’effetto opposto. Ad esempio il personaggio rappresentante la madre del soggetto dapprima può trasformarsi in una strega ed, infine, in un animale. Tali trasformazioni permetterebbero al sognatore di comprendere la natura del conflitto inconscio che si celerebbe dietro gli incubi notturni. In ciò starebbe l’azione diagnostica del programma. L’azione terapeutica, invece, sembrerebbe promanare dalla conciliazione raggiunta con i personaggi onirici terrorizzanti.
L’autore ha proposto il suo programma a 62 studenti che sono stati seguiti per almeno un anno dal momento in cui sono stati capaci di avere sogni lucidi. Ai soggetti fu poi chiesto di esprimere le proprie opinioni circa l’efficacia del trattamento. I dati riportati dall’autore sembrano deporre a favore dell’efficacia del programma di auto-guarigione sviluppato da Tholey e fondantesi sullo strumento del sogno lucido. Nel 77% dei casi i personaggi onirici ostili hanno perso il loro carattere spaventoso, mentre nel 33% è stata raggiunta una riconciliazione con essi. I benefici sembrano essere stati trasmessi anche alla vita di veglia. I soggetti, infatti, hanno riferito di essersi sentiti meno ansiosi (67%), più equilibrati emotivamente (45%), più aperti mentalmente (42%) e più creativi (30%). Da un punto di vista psicoanalitico risulta un incremento nella forza dell’Io, anche se l’autore preferisce utilizzare i termini: "conferma del coraggio".
Tholey riferisce di aver utilizzato il programma di auto-guarigione anche con pazienti nevrotici in psicoterapia. I pazienti presentavano, combinati secondo diverse sindromi, i seguenti sintomi: incubi ricorrenti; ansietà; fobie; depressione; sintomi psicosomatici; dipendenze da droghe; difficoltà di adattamento sociale come ad esempio la timidezza. Il programma non è stato, invece, offerto in caso di: basso Quoziente Intellettivo (inferiore a 90); scarsa motivazione a intraprendere il programma; diagnosi di tipo psicotico o pre-psicotico; patologie cerebrali di tipo organico. L’autore sostiene che il programma risulti essere molto efficace nell’eliminare gli incubi ricorrenti, e che, nella maggioranza dei casi, i pazienti traggano un vantaggio anche per quanto concerne i sintomi della vita della veglia.
Peter Fellows: auto-stima e integrazione psicologica
Fellows [1988] ha utilizzato lo strumento del sogno lucido con i propri studenti e clienti. Egli ha sottolineato l’importanza dello "spazio alternativo" del sogno lucido, che permetterebbe di sperimentare condotte nuove senza dover assumersi la responsabilità delle conseguenze. Il sognatore avrebbe in questo "spazio" l’occasione di cambiare ciò che non gli aggrada, e di mettere in atto ciò che desidera. Secondo l’autore queste possibilità fornirebbero al soggetto l’occasione per sperimentare una aumentata fiducia nelle proprie capacità decisorie che si trascinerebbe anche nella vita della veglia.
I soggetti, che si lamentano di non riuscire a esprimersi totalmente in termini di emozioni e di azioni durante la veglia, avrebbero finalmente la possibilità di mostrarsi nella propria autenticità. Questa possibilità si tradurrebbe in una accresciuta auto-consapevolezza, in una maggiore auto-stima, in uno stile comportamentale più assertivo nella veglia. Secondo l’autore questi risultati sarebbero proporzionali all’impegno mostrato dai soggetti in questo lavoro all’interno dei sogni lucidi.
Molto interessante sembra essere l’esercizio svolto durante il sogno lucido e chiamato da Fellows "aspect integration": integrazione degli aspetti della personalità. L’autore parte dall’ipotesi che ciascun elemento e personaggio all’interno di un sogno lucido sia un riflesso o una proiezione della personalità del sognatore. Così gli elementi percepiti come ostili rifletterebbero dei conflitti inconsci, degli elementi "scissi". Fellows incoraggia i suoi soggetti ad assimilare tali elementi conflittuali al fine di aumentare l’integrazione della propria personalità e l’armonia psichica. I modi in cui tale integrazione si compirebbe sono molteplici. Talvolta i soggetti risolverebbero i propri conflitti instaurando un dialogo con i personaggi onirici ostili, instaurando una interazione improntata sulla comprensione reciproca. Altre volte i soggetti sono incoraggiati ad entrare all’interno dei personaggi onirici al fine di assumere il loro punto di vista. La comprensione che sembrerebbe scaturirne, comprensione emotiva più che cognitiva, porterebbe il soggetto ad una accettazione/auto-accettazione dell’aspetto della propria personalità con cui è in conflitto. L’intero lavoro suggerito dall’autore permetterebbe di sviluppare maggiori auto-stima e armonia psichica durante la veglia.
Halliday: i limiti dell’applicazione clinica del sogno lucido
Halliday [1988] ha attirato l’attenzione sulle possibili difficoltà applicative dello strumento del sogno lucido, in modo particolare per quanto riguarda il suo utilizzo nel trattamento degli incubi. Secondo l’autore il sogno lucido sarebbe uno degli strumenti a disposizione del terapeuta nel trattamento degli incubi, e non lo strumento.
Halliday, inoltre, sostiene che alcuni soggetti, sviluppando la capacità di avere sogni lucidi, addirittura peggiorerebbero la propria situazione. Questo è il caso del paziente, descritto dall’autore [Halliday, 1988, p.306], che soffriva dell’incubo ricorrente di affogare. Il soggetto una volta divenuto lucido ha visto peggiorare la propria situazione di sofferenza: non solo non era in grado di controllare il contenuto dell’incubo, ma provava anche un sentimento di panico claustrofobico all’idea di star sognando e di non riuscire a smettere.
Il contributo di Halliday stimola ad una maggiore riflessione circa le potenzialità e i limiti dello strumento del sogno lucido.
L’autore ha notato che l’uso del sogno lucido in terapia dovrebbe essere accuratamente valutato a seconda delle potenzialità del paziente. Vi sono individui che, una volta divenuti lucidi, non riescono a fronteggiare gli elementi ostili del sogno. In questi casi sembrerebbe inutile forzare il soggetto ad un confronto al di là della sua portata. L’autore ha, invece, notato come anche solo lo sforzo nel controllo di un elemento secondario del sogno possa apportare dei benefici. Ad esempio [Halliday, 1982] l’autore racconta di un soggetto che, soffrendo di incubi ricorrenti in cui veniva inseguito da un trattore, e sviluppata la capacità di avere sogni lucidi, fu incoraggiato a fronteggiare direttamente il trattore e a sbarazzarsene. Non riuscendo ad eseguire il compito, il soggetto fu incoraggiato a cambiare il colore di un oggetto dello sfondo. Il successo in questo compito secondario fu accompagnato da un benefico effetto nella sua vita onirica, perdendo l’incubo parte del proprio potere terrorifico.
Malamoud: divenire pienamente lucidi
Essere pienamente lucidi mentre si sta sognando significa essere consapevoli che il sogno che si sta vivendo sia interamente una propria creazione mentale, controllabile a piacimento. "Se non voli perché pensi di non riuscirci non sei completamente lucido", afferma LaBerge [Hooper Teresi, 1986, p.339]. Inoltre significa "comprendere emotivamente" che ogni cosa, anche le emozioni che si stanno vivendo, provengono dal proprio apparato psichico. Malamud [1988] incoraggia i suoi soggetti a divenire pienamente lucidi, sottolineando l’importanza di questa "comprensione emotiva" piuttosto che la "comprensione intellettuale". Allorché gli individui diventano pienamente lucidi, afferma Malamoud, cominciano a sentire, oltre che a sapere, che il mondo onirico è interamente una creazione psichica. Tale comprensione si trasferirebbe parzialmente anche nella vita della veglia, rendendo consapevoli i soggetti del proprio potere e della propria responsabilità nella creazione della propria visione del mondo.
A detta dell’autore gli individui diventerebbero più sicuri di sé, più orgogliosi nel sentirsi creatori delle proprie esperienze della veglia e del sogno. Questo cambiamento nella visione del mondo e di sé aumenterebbe la capacità di assumere responsabilità e di scegliere in modo libero anche nella veglia.
Sviluppare una piena lucidità non è, comunque, un compito semplice. Per sviluppare la padronanza necessaria alla "comprensione emotiva" che il mondo onirico sia una creazione completamente mentale, occorrono una forte motivazione e un impegno prolungato. Molto spesso, infatti, i sognatori lucidi hanno esperienze estremamente brevi, confuse ed effimere e si accontentano di esse. Per portare i soggetti ad una comprensione graduale del proprio ruolo creativo nella sfera onirica, l’autore ha, quindi, suggerito di cominciare con l’osservazione della proprie fantasie durante la veglia. Il soggetto dovrebbe stare attento a cogliere l’inizio del proprio fantasticare al fine di vederne la provenienza. Cominciare a comprendere il proprio ruolo creativo riguardo alle fantasie sarebbe un buon inizio per sviluppare la suddetta "comprensione emotiva".
Gli sforzi ulteriori che i sognatori lucidi sono invitati a fare per divenire pienamente lucidi consistono nell’assumere, durante il sogno lucido, uno stato mentale rilassato, di attesa e di ricezione. Il sognatore potrebbe in questo modo imparare ad ascoltare le proprie emozioni e a vedere i propri meccanismi simbolici di rappresentazione mentre sono all’opera. In tal modo diverrebbe anche consapevole del proprio linguaggio metaforico individuale utilizzato nella produzione onirica e fantastica.
Prospettive applicative e di ricerca future
Da quando si è cominciato a studiare il sogno lucido all’interno dei laboratori del sonno, sono state accumulate osservazioni e descrizioni dei processi fisiologici concomitanti. La verifica del sogno lucido attraverso la comunicazione volontaria durante il sonno REM, ha rappresentato un punto di svolta nello studio di questo fenomeno, permettendo di affermarne la realtà da un punto di vista scientifico. Il resoconto della suddetta verifica è stato pubblicato per la prima volta nell’articolo diLaBerge, Nagel, Dement e Zarcone del 1981: "Lucid dreaming verified by volitional communication during REM sleep". Gli autori sostenenvano di aver registrato attraverso il polisonnografo dei segnali, preventivamente concordati con i soggetti, inviati volontariamente attraverso i movimenti oculari e le contrazioni della muscolatura degli avambracci da parte di soggetti durante la fase REM del sonno.
La presenza di una comunicazione volontaria durante la fase REM testimonierebbe la consapevolezza dei soggetti addormentati e, quindi, la realtà del sogno lucido.
Si potrebbe affermare che quasi tutte le ricerche sull’argomento in ambito psicofisiologico successive si siano riferite al citato articolo per sostenere l’evidenza empirica del fenomeno, o per utilizzarne la stessa metodologia di ricerca.
Tuttavia occorre far notare che la procedura adottata dagli sperimentatori nell’articolo citato non è chiara né rigorosa. Ad esempio gli autori affermano di aver concordato con i soggetti una varietà di segnali da effettuare attraverso i movimenti oculari e la contrazione della muscolatura degli avambracci. Quali e quanti erano tali segnali?
I soggetti erano lasciati liberi di svegliarsi spontaneamente. Una procedura che avesse svegliato i soggetti rispetto a condizioni sperimentali diverse, ossia in presenza o in assenza del segnale concordato, avrebbe permesso di controllare maggiormente la validità interna dell’esperimento.
Ad un giudice, cieco rispetto al momento in cui la seganalazione era avvenuta, sono stati sottoposti i tracciati polisonnografici con il compito di individuare i segnali concordati. Al giudice sono stati sottoposti unicamente tracciati in cui si supponeva ci fossero i segnali concordati. Perché non sottoporre al giudice anche tracciati relativi a notti senza sogni lucidi riferiti?
Un’altra esigenza di ricerca sarebbe stata quella di verificare preventivamente l’abilità dei soggetti a resistere alla suggestione allorché venivano loro poste domande circa l’attività onirica.
Si sente, dunque, la necessità di replicare l’esperimento di verifica del sogno lucido attraverso la comunicazione volontaria. L’esigenza di un esperimento più rigoroso dal punto di vista della capacità di escludere la presenza di bias è tanto più forte se si considera l’importanza storica che il citato articolo ha di fatto acquisito nel campo della ricerca scientifica sul sogno lucido.
Come ha notato LaBerge [1993] le attuali conoscenze non permettono di avere una sufficiente comprensione dei fattori psicofisici tale da permettere a un qualsiasi individuo di vivere l’esperienza a proprio piacimento. La sfida che l’autore si propone è quella di individuare, attraverso un’intensa ricerca futura, i fattori relativi al cervello, al corpo e allo psichismo che permettano di raggiungere e di mantenere il traguardo del sogno lucido. Ad esempio al momento non è chiaro se il fenomeno sia caratterizzato da una attività elettroencefalografica specifica e diversa da quella del "sogno ordinario". Le ricerche esistenti sull’argomento non hanno valore definitivo.
Riamane aperto, inoltre, il quesito se il sogno lucido determini un’attivazione fisiologica, ovvero se quest’ultima sia una conseguenza della segnalazione attraverso movimenti oculari, compito che molto spesso è parte integrante della metodologia di studio all’interno dei laboratori del sonno.
Il campo che sembra necessitare maggiormente di ulteriori ricerche sembra essere quello relativo all’individuazione delle caratteristiche psicologiche associate con la presenza o la maggiore frequenza dei sogni lucidi.
Un dato certo sembra essere la relazione del fenomeno in esame con il costrutto di "campo-indipendenza/campo-dipendenza". Meno certe sembrano, invece, le relazioni individuate con costrutti quali: l’intelligenza non verbale, la creatività verbale e non verbale. Le ricerche esistenti, presentando dati contraddittori, non hanno un valore definitivo.
Alcuni autori [Snyder, Gackenbach, 1988] hanno ipotizzato che i sognatori frequentemente lucidi presentino un orientamento intrapersonale e un’alta suscettibilità all’ansia. I dati a conferma di questa ipotesi, tuttavia, o sono ambigui e scarsamente interpretabili (come nel caso dello studio sul livello di ansietà tra i sognatori lucidi, in cui è stata notata una corrispondenza tra ansietà e frequenza di sogni lucidi solamente negli uomini, mentre nelle donne è stata riscontrata la relazione inversa), ovvero sono palesemente contraddittori. Alcune ricerche hanno individuato un orientamento intrapersonale tra i sognatori lucidi, altre ricerche hanno trovato un orientamento interpersonale tra gli stessi.
Una relazione interessante è stata evidenziata da Wolpin, Marston, Randolph, Clothier [1992]. Gli autori hanno rilevato una correlazione positiva tra benessere percepito soggettivamente e frequenza dei sogni lucidi. La ricerca, tuttavia, è isolata e necessiterebbe delle conferme, che apporterebbero valore anche alle promettenti testimonianze circa l’utilizzo del sogno lucido come strumento terapeutico.
Le tecniche di induzione del sogno lucido sono molteplici. Nonostante questo, non vi sono adeguate informazioni circa l’efficacia delle medesime. I diversi autori, o non riportano assolutamente nessun tentativo di verifica delle tecniche da essi suggerite, o si limitano a fornire isolate ricerche per lo più con un numero di soggetti sperimentale troppo esiguo.
Attenti a verificare l’efficacia della tecnica da essi proposta sono stati LaBerge [1987], LaBerge e Levitan [1995]. In particolare essi hanno dimostrato, avvalendosi della metodologia della comunicazione volontaria attraverso movimenti oculari, la validità dell’utilizzo di stimoli visivi nell’elicitare l’esperienza.
Sembra importante, tuttavia, conoscere anche la validità degli strumenti e delle tecniche per quanto riguarda l’acquisizione nel lungo termine della capacità di avere sogni lucidi. In che misura gli strumenti e le tecniche proposte permettono alle persone di acquisire la possibilità di avere sogni lucidi in un modo stabile nel tempo?
E’, dunque, importante che la ricerca futura si occupi di verificare la validità delle tecniche proposte sia nella loro capacità di elicitare le esperienze nel breve periodo e sia nella loro capacità di permettere un apprendimento duraturo nel tempo.
Da una parte la suggestione post-ipnotica sembra in grado di produrre il fenomeno, dall’altra è stato notato che durante uno stato di leggera ipnosi i sogni lucidi possono comparire spontaneamente. Sembra, dunque, esistere un rapporto tra il fenomeno in esame e l’ipnosi. Ma tale relazione non è chiara. Si attendono delucidazioni circa le specifiche modalità con cui lo strumento dell’ipnosi rende possibili le esperienze di sogno lucido.
Le proposte applicative dello strumento sogno lucido sono varie e diverse. Ciò è dovuto al fatto che spesso i diversi autori hanno pubblicato le loro ipotesi e convinzioni, sviluppandole a partire dalla propria individuale esperienza di terapista.
Alla luce di questa pluralità di interventi le potenzialità derivanti dall’utilizzo del sogno lucido in clinica sembrano essere promettenti. Tuttavia ad oggi rimane aperto il quesito se le prove empiriche del successo clinico siano sufficienti per ammetterne l’utilizzo. Il quesito risulta particolarmente pertinente se si considera il fatto che lo sviluppo della capacità di avere sogni lucidi sembra implicare un grande impegno da parte del paziente.
Gli interventi degli autori richiedono ulteriori conferme. Lo sforzo richiesto in tal senso sembra essere giustificato dalle incoraggianti testimonianze cliniche di cui disponiamo oggi.
In questo paragrafo si è fatto ripetutamente appello alla necessità di approfondire diversi argomenti inerenti allo studio del sogno lucido, mostrando le lacune e le incertezze del presente stato della ricerca. Ma bisogna anche sottolineare la novità dell’interesse della ricerca in questo settore, per apprezzare la portata degli sforzi che i diversi autori hanno compiuto nel gettare luce sul fenomeno.
La prima volta che il sogno lucido è stato studiato all’interno di un laboratorio del sonno risale al 1978 [Hearne, 1978]. Fino a quell’anno il sogno lucido è stato un oggetto di studio largamente ignorato. Se si riflette sul fatto che dall’articolo di Hearne sono passati poco più di venti anni, si può comprendere la portata dell’interesse che è stato suscitato dal fenomeno del sogno lucido nelle diverse discipline. Ed in effetti negli ultimi venti anni tale aumento di interesse è stato testimoniato dal crescente numero di articoli su riviste scientifiche, dal comparire di pubblicazioni più o meno divulgative, dal sorgere di riviste, associazioni, fondazioni e siti della rete informatica Internet. L’attenzione verso il sogno lucido è andata progressivamente aumentando sia nel mondo della ricerca che tra il grande pubblico, promettendo al primo nuove chiavi per comprendere i fenomeni del sogno, del sonno e dello psichismo in generale, affascinando il secondo per le sue possibilità di avventura e di conoscenza di sé.
Ipotesi teoriche: la consapevolezza
Tart [1975], all’interno del suo approccio per sistemi agli stati di coscienza, descrive il sogno lucido come uno stato di coscienza discreto, secondo la sua dicitura un d-SoC ("discrete State of Consciousness").
Secondo l’autore ogni d-SoC sarebbe caratterizzato da uno specifico spazio esperienziale entro il quale i diversi sottosistemi fondamentali della coscienza (esterocezione, enterocezione, elaborazione dell’input, memoria, subconscio, valutazione e decisione, emozioni, senso di spazio/tempo, senso di identità, output motore) sarebbero presenti secondo modalità e intensità specifiche. La diversità tra stati di coscienza sarebbe di tipo discreto, non esistendo, quindi, gradazioni intermedie tra di essi. Il passaggio da uno d-SoC all’altro avverrebbe per "salti quantici".
Al fine di semplificare la descrizione dei d-SoC, Tart stabilisce di considerare solo due dimensioni psicologiche tra le molteplici possibili: la capacità di immaginazione o di allucinazione e la razionalità. La capacità di allucinazione varierebbe da un "minimo di immaginazione di qualcosa al di fuori di voi stessi ma con niente che corrisponda in intensità a una percezione sensoriale, fino a un massimo di immaginazione di qualcosa che possiede tutte le qualità della realtà, della reale percezione sensoriale" [Tart, 1975, p.65]. La razionalità sarebbe, invece, la capacità di pensare secondo una qualsiasi logica, ossia un insieme di regole, a prescindere dal contesto culturale, variando da " un minimo in cui si fanno molti errori nell’applicazione di questa logica, come ad esempio nei giorni in cui vi sentite un po’ stupidi e avete difficoltà nell’esprimervi, fino a un massimo in cui si seguono le regole della logica alla perfezione, quando vi sentite in forma e la vostra mente funziona come un computer di precisione" [ibidem, p.65]. Incrociando le due dimensioni Tart disegna il seguente quadro sinottico:
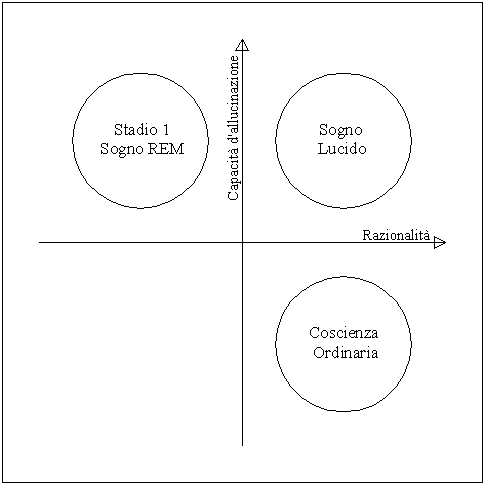
Fig.2 [Tratta da: Tart, 1975; Trad. it. 1977, p.65]
Si consideri ora il concetto di "cosapevolezza". Introduco il concetto di "consapevolezza" senza affrontare il problema della distinzione tra coscienza e consapevolezza. Considero la "consapevolezza" una esperienza fenomenica soggettiva e inaccessibile all’osservatore esterno, intendendola come la capacità di avvertire se stessi, i propri contenuti e processi mentali e le proprie percezioni. Tale capacità varierebbe inter- e intra-individualmente. A mio parere la dimensione psicologica della "consapevolezza" getterebbe un poco più di luce sulla fenomenologia considerata, permettendo di distinguere in modo più preciso tra sogno "ordinario" e sogno lucido. Modificherei, dunque, il grafico nel seguente modo (Fig.3):
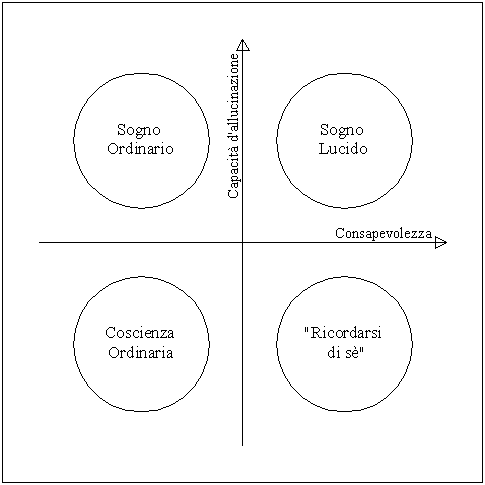
Fig. 3
Entrambi i concetti: "razionalità" e "consapevolezza" sono di difficile definizione e comprensione, tuttavia si può dire che la "consapevolezza" venga prima della razionalità, ne sia la condizione necessaria. Non si può applicare una regola logica, ad esempio il principio di identità e non contraddizione della logica aristotelica ( che ad oggi fonda il cosiddetto modo di pensare razionale occidentale), se non si è prima "consapevoli" della violazione e quindi dell’esistenza di detta regola logica. Ad esempio poiché durante lo stato di sogno "ordinario" non si è "consapevoli" di se stessi come dormienti, né del contenuto mentale "principio di identità e non contraddizione", un personaggio onirico può in un dato momento rappresentare la zia X e nel momento successivo lo zio Z senza che colui che sta sognando colga la violazione del suddetto principio e ragioni in modo razionale. Allorché si rende conto della violazione della regola logica (si ricorda dunque dell’esistenza di una regola logica) il soggetto diviene consapevole della stranezza della esperienza. Tale constatazione può a sua volta renderlo consapevole di trovarsi nel d-SoC di sogno lucido. E’ proprio tale incremento di "consapevolezza" che distingue il sogno "ordinario" dal sogno lucido.
Nello stato di veglia la dimensione psicologica della "consapevolezza" permette di distinguere due spazi esperenziali diversi: la "coscienza ordinaria" e lo stato di coscienza definito da Ouspensky "ricordarsi di sé" [Ouspensky, 1949, p.134] in cui la consapevolezza di se stessi, dei propri contenuti e processi mentali e dei fenomeni percepiti è massima. I due "spazi esperenziali" richiamano la distinzione che Tart stesso introduce tra i due concetti di consapevolezza e di autoconsapevolezza [Tart, 1975, pp.25-26]. Tra i due "vi è un continuum esperenziale a un estremo del quale l’attenzione/consapevolezza e il contenuto particolare della consapevolezza si fondono essenzialmente, mentre all’altro estremo la consapevolezza di essere consapevoli esiste in aggiunta al contenuto particolare della consapevolezza. Tra di essi vi sono delle mescolanze". Concordo sull’esistenza di un continuum di "mescolanze" tra i due modi di funzionamento mentale. Per ragioni di chiarezza espositiva nel grafico sono invece riportati solamente la "coscienza ordinaria" e il "ricordarsi di sé", come se fossero due fenomeni di tipo discreto.
Nel grafico la "coscienza ordinaria" è posta a sinistra, essendo caratterizzata, a mio parere, da un minore livello di "consapevolezza" o, come dice Tart, da "un assorbimento relativamente totale nel contenuto particolare della consapevolezza".
Si potrebbe obiettare di essere in ogni momento di veglia pienamente consapevoli di se stessi, dei propri contenuti mentali e delle proprie percezioni. In realtà raramente ciò avviene, come hanno messo in evidenza, da oltre un secolo, le scoperte della psicoanalisi, tra le quali il concetto di rimozione e la distinzione tra conscio ed inconscio. Non si può più ignorare che modelli di comportamento e di pensiero automatico (i cosiddetti "meccanismi di difesa", ad esempio: la rimozione, la proiezione, la negazione, la scissione, la razionalizzazione, l’idealizzazione e la svalutazione, la formazione reattiva, l’annullamento retroattivo, ecc.) facciano parte del funzionamento mentale abituale, automatico e poco "consapevole" di soggetti "malati" e "non malati". Tali meccanismi, proteggendo dall’angoscia, nel senso che permettono di avere un basso livello di "consapevolezza" di essa, distorcono sistematicamente la visione di sé, dei contenuti del proprio mondo interiore e dei contenuti delle percezioni. Se tali meccanismi sono abituali della "normalità nevrotica", si può a buon diritto sostenere che la "coscienza ordinaria" sia denotata da un basso livello di "consapevolezza". Non sviluppo ulteriormente la discussione circa i fenomeni relativi alla veglia.
Nel tentativo di comprendere la differenza tra sogno ordinario e sogno lucido mi sembra importante sottolineare il ruolo della aumentata "consapevolezza" circa il proprio stato di coscienza nel determinare la comparsa della lucidità durante il sogno. A questo proposito mi sembra utile citare la ricerca di McLeod e Hunt circa la relazione tra meditazione e sogno lucido [McLeod, Hunt, 1983]. Gli autori hanno evidenziato una correlazione positiva tra anni di pratica meditativa e frequenza dei sogni lucidi. Questo, a mio parere, è dovuto proprio allo sviluppo della "consapevolezza", sviluppo che è l’obiettivo principale della pratica della meditazione. Tuttavia, nella stessa ricerca, è stato anche notato come una frequenza parimenti elevata fosse presente anche nel gruppo dei soggetti aventi un’alta capacità di ricordare i sogni ordinari. Se ne può dedurre che meditatori e soggetti con un’alta capacità di ricordare i sogni abbiano una caratteristica in comune, e che tale caratteristica, in un caso, sia stata sviluppata attraverso la meditazione, nell’altro, sia presente in modo spontaneo. Io identifico tale caratteristica nell’alto livello di questi soggetti nella dimensione della "consapevolezza".
La dimensione della "consapevolezza" varia in modo continuo anche per i fenomeni relativi al sonno, dando luogo ad una varietà di esperienze che non sono illustrate nel grafico e che esulano l’argomento di questo scritto. I "sogni ordinari" presentano notevoli differenze quanto a "consapevolezza" del sognatore. Alcuni sogni sono addirittura dimenticati, altri sono ricordati solo confusamente, altri colpiscono per la loro intensità, altri ancora presentano un così alto livello di "consapevolezza" da dar luogo alla fenomenologia del sogno lucido.
Anche all’interno del fenomeno sogno lucido vi sono notevoli differenze quanto a livello di "consapevolezza". In alcuni la lucidità, ossia la consapevolezza di star sognando, va e viene. In altri, pur rimanendo il sognatore sempre consapevole di star sognando, incorre in contraddizioni logiche (non essendo consapevole delle regole logiche che infrange). Ad esempio il soggetto può meravigliarsi che nel sogno non siano presenti degli elementi del mondo reale, non essendo quindi pienamente "consapevole" che l’esperienza che sta vivendo appartiene interamente al proprio mondo mentale. Malamud [1988] sostiene che essere pienamente lucidi, ossia consapevoli, mentre si sta sognando significhi essere consapevoli che il sogno che si sta vivendo sia interamente una propria creazione mentale, controllabile a piacimento.
La dimensione della consapevolezza non sembra raggiungere il massimo grado, per quanto riguarda le esperienze del sonno considerate nel loro insieme, nel sogno pienamente lucido. Alexander e colleghi hanno descritto [Alexander, 1987; Alexander, Boyer, Orme-Johnson, 1985] un fenomeno che comparirebbe successivamente al sogno lucido, con il procedere della pratica della meditazione trascendentale. Gli autori chiamano tale fenomeno "testimoniare" ("witnessing"), e lo distinguono dal sogno lucido, denotato da azione, in quanto caratterizzato da quiete e osservazione rilassata. L’esperienza si verificherebbe, in alcuni soggetti, anche durante il sonno non-REM. Quest’ultima affermazione risulta convalidata da quanto affermato da LaBerge, Nagel, Dement e Zarcone [1981]. Gli autori hanno verificato, mediante la metodologia della comunicazione attraverso movimenti oculari e le contrazioni della muscolatura degli avambracci, la presenza dei sogni lucidi al di fuori della fase REM. Osservazioni simili sono riportate da Gackenbach, Moorecroft, Alexander, Laberge [1987].
La dicotomica distinzione tra "sogno ordinario" e "sogno lucido", pur utile ai fini descrittivi, sembra essere approssimativa e semplicistica. I fenomeni relativi al sonno sembrano essere di più e più complessamente interrelati di quanto una prima osservazione lascerebbe credere. A mio parere la dimensione della "consapevolezza" potrebbe rivelarsi molto utile in una futura descrizione di tali eventi che tenga conto di tale complessità.
La dimensione psicologica della "consapevolezza" sembra essere foriera di interessanti sviluppi pratici e teorici sia per gli stati di veglia che per gli stati di sogno. Per quanto riguarda il sogno lucido la mia ipotesi è che la frequenza della lucidità sia correlata positivamente con la dimensione della "consapevolezza" durante la veglia.
Secondo il pensiero epistemologico di Karl Popper la suddetta ipotesi non è denotata da scientificità. L’autore sosteneva che una affermazione per essere scientifica deve poter essere smentita dai fatti osservabili. A tal fine i concetti contenuti nella affermazione scientifica devono, innanzi tutto, poter essere osservati secondo una modalità ripetibile dai diversi ricercatori.
Nella affermazione ipotetica: la frequenza della lucidità è correlata positivamente con la dimensione della "consapevolezza" durante la veglia, vi sono due concetti che occorre poter osservare affinché l’affermazione stessa possa essere considerata scientifica. I due concetti sono: la frequenza dei sogni lucidi dell’individuo e la dimensione della "consapevolezza" durante la veglia. In conclusione, in una lettura epistemologica popperiana, la scientificità di una affermazione è garantita dalla possibilità che i concetti su cui essa è costruita siano osservabili in modo consensuale e ripetibile dai diversi ricercatori. Questa esigenza viene talvolta denominata come il problema della "operazionalizzazione".
La frequenza dei sogni lucidi è un concetto che è stato operazionalizzato, è stato reso operativo, allorché si è introdotta in ricerca la §metodologia della verifica in laboratorio del sogno lucido§ attraverso i movimenti oculari del dormiente. Tale procedura permette, infatti, a qualsiasi ricercatore di osservare il verificarsi del sogno lucido con un soggetto a tal fine addestrato. Attraverso l’uso del polisonnografo il ricercatore può smentire o accertare che il fenomeno si presenti e, in tal modo, può misurarne la frequenza. La frequenza dei sogni lucidi è falsificabile.
Il termine consapevolezza è stato raramente definito, dando per scontato il suo significato. Ho precedentemente definito la consapevolezza come la capacità di avvertire se stessi, i propri contenuti e processi mentali e le proprie percezioni. Per il momento la dimensione viene utilizzata, con sfumature e accezioni diverse, in clinica in modo giocoforza arbitrario. La dimensione della "consapevolezza", intesa in questo senso, quindi come un’esperienza fenomenica soggettiva inaccessibile all’osservatore esterno, non è stata operazionalizzata, ossia non esiste un modo che permetta di osservarla in modo consensuale e ripetibile. Non si può escludere tale esperienza fenomenica soggettiva possa essere in futuro, in un modo che ad oggi sfugge, osservata nei suoi correlati fisici.
La mancata operazionalizzazione della dimensione della consapevolezza inficia il carattere di scientificità della suddetta ipotesi. Rimane il valore euristico della stessa.
Sonno e sogno lucido
Cicogna e Cavallero [1993, p.27] sostengono che il processo elaborativo mentale, che opera nella formazione del sogno, sia il medesimo in ogni stadio del sonno. I sogni REM sarebbero più lunghi solo perché in questa fase il numero degli elementi di memoria attivati sarebbe più elevato. L’ipotesi è, dunque, che il processo elaborativo mentale sia sempre dello stesso tipo per tutta la durata del sonno, presentando differenze di ordine quantitativo e non di ordine qualitativo.
Accettando quest’ipotesi e alla luce del fenomeno studiato, se ne potrebbe inferire la possibilità di divenire consapevoli di star dormendo e dei processi elaborativi mentali del sonno per tutta la durata di esso e realizzare un lunghissimo sogno lucido della stessa durata del sonno. In realtà questo è quanto è stato dichiarato di poter fare da un soggetto studiato da Gackenbach, Moorecroft, Alexander, Laberge [1987], il quale si dimostrò capace di inviare segnali attraverso i movimenti oculari dalla fase REM, nonché dalle fasi 1 e 2 non-REM (sono state documentate segnalazioni volontarie dalle fasi 1 e 2 del sonno anche da parte di altri autori [LaBerge, Nagel, Dement e Zarcone 1981], in questi casi i soggetti non hanno, però, affermato di mantenersi consapevoli durante tutta la durata del sonno).
Alla luce di questo dato, e tenendo conto della necessità di verifiche future, il sonno perderebbe la caratteristica, tradizionalmente attribuitagli, di inconsapevolezza/incoscienza, che presuppone la perdita della capacità di sapere cosa realmente sta avvenendo. Tradizionalmente si attribuisce al dormiente l’incapacità di sapere di star dormendo. Ma l’esistenza stessa del sogno lucido e la possibilità che la lucidità si estenda a tutto l’arco del sonno si oppongono a questa tradizionale convinzione.
La caratteristica di inconsapevolezza/incoscienza non distingue, dunque, la veglia dal sonno. Cosa li distingue?
Semplificando si potrebbe affermare che il sonno sia un comportamento istintivo denotato da specifici fenomeni psicofisici, come: l’alternarsi di periodi con onde EEG ampie e lente e periodi con onde EEG di basso voltaggio e rapide; la caratteristica atonia muscolare della fase REM; un innalzamento delle soglie percettive affinché gli stimoli diventino percezioni (a prescindere dal fatto che il sognatore poi si svegli o incorpori lo stimolo nell’attività mentale concomitante)… Tuttavia il comportamento istintivo del sonno, o meglio, i comportamenti istintivi del sonno sono stati frequentemente e automaticamente associati alla diminuita consapevolezza del dormiente circa il fatto di giacere in un letto e ,appunto, dormire. McClintic [1975] così definiva il sonno: "Il sonno è la sospensione dello stato di coscienza e dei processi mentali associati ad esso". Questo tradizionale modo di concepire il sonno da parte del mondo scientifico, alla luce del sogno lucido, non è più sostenibile.
Durante il sonno si può divenire "consapevoli" dello stato di sonno. Diverse ricerche sembrano mostrare che un soggetto addormentato possa comunicare con il mondo esterno attraverso i movimenti oculari. Tale comunicazione, evidenza della raggiunta "consapevolezza" di star dormendo o lucidità, sembra, inoltre, poter aver luogo nelle due direzioni: dal dormiente all’osservatore esterno, dall’osservatore esterno al dormiente. L’ultimo caso è stato osservato da Fenwick et al. [1984], che hanno mostrato come il loro soggetto fosse capace di percepire e di rispondere attraverso i movimenti oculari a stimoli esterni di natura elettrica senza svegliarsi dal suo sogno lucido.
Dunque non possono essere presi come spartiacque di sonno e veglia né l’inconsapevolezza/incoscienza, né il criterio della perdita della capacità di percezione del mondo esterno (come, tra l’altro, è stato notato anche a proposito della selettiva capacità delle madri di percepire i suoni emessi dal proprio bambino). Cosa distingue allora il sonno dalla veglia?
Forse i due fenomeni non sono così nettamente distinguibili. Antrobus et al. [1965, pp.398-399, traduzione mia] scrivevano: "La questione -veglia o sonno- non è particolarmente utile. Anche se possediamo due parole di ordine discreto -sonno e veglia- ciò non significa che il comportamento associato con queste parole possa essere ricondotto a forza entro due categorie di ordine discreto.[…] non solo sonno e veglia sfumano gradualmente l’uno nell’altra, ma c’è solo un basso livello di consenso circa le varie operazioni fisiologiche e soggettive che discriminano tra sonno e veglia. In un certo momento, tutti i sistemi dell’organismo non sono necessariamente o tutti addormentati o tutti svegli".
La confusione è nata, a mio parere, dal fatto che spesso, in concomitanza del funzionamento istintuale e automatico di alcuni sistemi (ad esempio quello preposto all’atonia muscolare della fase REM), è stata riscontrata una diminuzione di "consapevolezza". Tale associazione –comportamento istintivo di un dato sistema e diminuzione della "consapevolezza"- è stata, col tempo, data per scontata fino a far coincidere i fenomeni. In questo modo il pensiero analitico ha perso di chiarezza, confondendo la natura dei fenomeni, e andando a studiare il sonno nei termini di inconsapevolezza/incoscienza.
Riportando il pensiero analitico, scevro da questa confusione, sul problema della distinzione tra sonno e veglia, forse potremmo osservare, come sostenevano Antrobus et al., che non esistono solamente due fenomeni –sonno e veglia- di ordine discreto, ma una pluralità di fenomeni che sfumano l’uno nell’altro. A questo punto si potrebbe parlare di una pluralità di "condizioni di funzionamento" diverse. E tale diversità sarebbe di ordine continuo. Le diverse "condizioni di funzionamento" sarebbero la manifestazione individuale o combinata dei diversi sistemi funzionali, innati o appresi, che definiscono tutta l’attività del sistema nervoso [Anochin, 1975]. Secondo Anochin il sistema nervoso funzionerebbe per combinazioni e interazioni di sistemi funzionali innati e appresi. I sistemi funzionali avrebbero in comune il fatto che la loro attività/manifestazione passerebbe sequenzialmente per le seguenti quattro fasi : a) la sintesi di determinate informazioni (afferenze) provoca la "presa di decisione" seguita b) dalla "programmazione" della risposta propria dello specifico sistema funzionale, c) dalla "realizzazione del programma, d) dalla verifica della corretta esecuzione della risposta secondo il programma.
In quest’ottica i sistemi funzionali relativi al sonno sarebbero una pluralità. Si tratterebbe di individuarli e descriverli nel loro attivarsi in modo individuale o in modo combinato. Si pensi, ad esempio, al sistema funzionale relativo all’atonia muscolare della fase REM, e al sistema funzionale relativo all’innalzamento delle soglie percettive. Nel "sogno ordinario" entrambi i sistemi funzionali sono presenti, nella paralisi notturna è presente solo quello relativo all’atonia muscolare.
Una concezione che si fondi sui sistemi funzionali permetterebbe di superare l’idea di pochi "stati di coscienza" [Tart, 1975] rigidamente separati (sogno, sonno, veglia…) lasciando aperta la possibilità di considerare la più ampia pluralità di "condizioni di funzionamento" dell’organismo. Quest’ottica permetterebbe di descrivere in termini di sistemi funzionali fenomeni ad oggi male inquadrati, quali: il sonno, la veglia, l’ipnosi, il sogno lucido, il sonnambulismo, le paralisi notturne, al di là della rigida categorizzazione odierna.
Quale è la differenza tra sonno e veglia, dunque? Da questo punto di vista sarebbero due "condizioni di funzionamento" dell’organismo diverse, implicanti sistemi funzionali in parte diversi. Si potrebbero considerare sonno e veglia come due "condizioni di funzionamento" di ordine generale che presumibilmente potrebbero essere meglio analizzate suddividendole in "condizioni di funzionamento" meno generali e più particolari.
Tale progresso verso il particolare, il procedere del pensiero analitico, chiaramente sarebbe subordinato alla bontà del processo analitico stesso: quanti più sistemi funzionali si individuassero e descrivessero, tanto maggiori sarebbero le possibilità di distinguere "condizioni di funzionamento" più particolari della veglia e del sonno.
Una descrizione in questi termini delle diverse "condizioni di funzionamento" dell’organismo potrebbe felicemente avvalersi della dimensione della "consapevolezza". La "consapevolezza", precedentemente definita come esperienza fenomenica soggettiva, sfugge alla concettualizzazione nei termini dei sistemi funzionali in quanto non presenta una specifico programma di azione/risposta.
L’utilizzo della dimensione della "consapevolezza" potrebbe funzionare come un ponte di collegamento nella descrizione delle "condizioni di funzionamento" dell’organismo, tenendo conto dei vari livelli con cui essa è presente.
In questa proposta si è consapevoli della precedentemente notata mancanza di operazionalizzazione della dimensione della "consapevolezza". Con questa ulteriore proposta, tuttavia, il problema si amplia dovendo rendere operativo il costrutto nelle diverse "condizioni di funzionamento", e non più solo durante la veglia. Come misurare il livello di consapevolezza di un sonnambulo?
Bibliografia
Abramovitch, H.
The nigntmare of returning home: a case of acute onset nightmare disorder treated by lucid dreaming. Israel Journal of Psychiatry, 32, 2, 140-145, 1995.
Alexander, C.
Dream lucidity and dream witnessing; a developmental model based on the practise of Trascendental Meditation. Lucidity Letter, 6, 2, 113-124, 1987.
Alexander, C., Boyer, R., Orme-Johnson, D.
Distinguishing between trascendental consciousness and lucidity. Lucidity Letter, 4, 2, 68-85, 1985.
Anochin, P. K.
Biologia e neurofisiologia del riflesso condizionato. Bulzoni, Roma, 1975.
Antrobus, J. S., Fisher, C.
Discrimination of dreaming and nondreaming sleep. Archives of General Psychiatry, 12, 395-401,1965.
Aquinas, St. Thomas
Summa Theologica. Vol.1. Benziger, New York, 1947.
Aristotele
On Dreams. IN: Huthinson, R. M. (Ed.). Great books of the Western world. Vol.8, 702-706. Encyclopedia Britannica, Chicago, 1952.
Blackmore, S.
More sex differences in lucid dream frequency. Lucidity Letter, 1 (2), 9, 1982.
Blackmore, S.
A survey of lucid dreams, OBE’s and related experiences. Lucidity Letter, 2 (3), 1, 1983
Blagrove, M., Tucker, M.
Individual differences in locus of control and reporting of lucid dreaming. Personality and Individual Differences, 16, 981-981, 1994.
Brown, A. E.
Dreams in which the dreamer knows he is asleep. Journal of Abnormal Psychology. 31, 59-66, 1936.
Brush, C. B.
The selected works of Pierre Gassendi. Johnson Reprint Corp., New York, 1972.
Brylowski, A.
H-reflex suppression and autonomic nervous system activity during lucid REM sleep. Sleep Research, 16, 227, 1987.
Brylowski, A., Levitan, L., LaBerge, S.
H-reflex suppression and autonomic activation during lucid REM sleep: A case study. Sleep, 12 (4), 374-378, 1989.
Brylowski, A.
Nightmares in crisis: clinical application of the lucid dreaming technique. Psychiatric Journal of the University of Ottawa, 15, 2, 79-84, 1990.
Castaneda, C.
Tales of power. Simon & Schuster, New York, 1974.
Trad it.: L’isola del Tonal. Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1975.
Cicogna, P., Cavallero, C.
Coscienza e sogno. Rivista di Psicologia, 1-2-3, Gen-Dic, 1993.
Clerc, O.
Natural induction of lucid dreams. Lucidity Letter, 2 (1), 4-5, 1983.
Dane, J.
A possible "new" technique for lucid dream induction. Dream Network Bullettin, 1, 59, 7, 1982.
Dane, J.
An empirical evaluetion of two techniques for lucid dream induction. Doctoral dissertation, Georgia State University, Atlanta, 1984.
DeBecker, R.
The understanding of dreams. Allen & Unwin, London, 1965.
Delage, Y.
Le Reve. Les presses universitaires de France, Paris, 1919.
Dentan, R. K.
Lucidity, sex and horror in Senoi dreamwork. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Evers, R. A., Van de Wetering, B. J.
Lucide dromen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 35, 10, 651-660, 1993.
Eysenck, H. J.
Pesonality, genetics and behaviour: Selected papers. New York, Praeger Publishers, 1982.
Fellows, P.
Working within the lucid dream. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Fenigstein, A., Scheier, M. F., Buss, A. H.
Public and private self-consciousness: Assessments and theory. Journal of Cosulting and Clinical Psychology, 43 (4), 522-527, 1975.
Fenwick, P., Schatzman, M., Worsley, A., Adams, J., Stone, S., Baker, A.
Lucid dreaming: Correspondence between dreamed and actual events in one subject during REM sleep. Biological Psychology, 18, 243-253, 1984.
Finke, R. A.
Levels of equivalence in imagery and perception. Psychological Review, 87, 113-132, 1980.
Fox, O.
Astral projection. Univerity Books Inc., New York, 1962.
French, C. C., Beaumont, J. K.
A critical review of EEG coherence studies of hemisphere function. International Journal of Psychophysiology, 1, 241-254, 1984.
Gackenbach, J. I.
A personality and cognitive style analyses of lucid dreaming. Doctoral dissertation. Virginia Commonwealth University, 1978.
Gackenbach, J. I.
Sex differences in lucid dreaming frequency: A second look. Lucity Letter, 4 (1), 11, 1985
Gackenback, J. I.
Psychological content of lucid versus non lucid dreams. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Gackenback, J. I.
Interhemispheric EEG coherence in REM sleep and meditation: The lucid dream connection. In: Antrobus, J. S., Bertini, M. (Eds.): The neuropsychology of sleep and dreaming. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Hillsdale, 265-288, 1992.
Gackenback, J. I., Cranson, R., Alexander, C.
Lucid dreaming, witnessing dreaming and trascendental meditation technique: A developmental relationship. Lucidity Letter, 5, 34-40, 1986.
Gackenbach, J. I., Curren, R., LaBerge, S., Davidson, D., Maxwell, P.
Intelligence, creativity and personality differences between individuals who vary in selfreported lucid dream frequency. Lucidity Letter, 2 (2), 52, 1983.
Gackenbach, J. I., Hammons, S.
Lucid dreaming ability and verbal creativity. Dreamworks, 3 (3), 219-223, 1983.
Gackenbach, J. I., Heilman, N., Boyt, S., Laberge, S.
The relationship between fild indipendence and lucid dream ability. Journal of Mental Imagery, 9 (1), 20, 1985.
Gackenback, J. I., Moorecroft, W., Alexander, C., LaBerge, S.
Physiological correlates of "consciousness" during sleep in a single TM practioner. Sleep Research, 16, 230, 1987.
Gackenbach, J. I., Sachau, D., Rokes, L.
Vestibolar sensitivity and dynamic and static motor balance as a function of sex and lucid dreaming. Sleep Research, 11, 104, 1982.
Gacknbach, J. I., Snyder, T. J., McKelvey, K., McWilliams, C., Gerge, E., Rodenelli, B.
Lucid dreaming: Individual differences in perception. Sleep Research, 10, 146, 1981.
Gackenbach, J. I., Snyder, T. J., Rokes, L. M., Sachau, D.
Lucid dreaming frequency in relation to vestibolar sensitivity as misured by caloric stimulation. IN: Haskell, R. (Ed.): Cognition and dream research, Special issue of the Journal of Mind and Beaviour, vol.2 (2,3), 277-298, 1986.
Garfield, P.
Introductory comments. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Green, C.
Lucid dreams. Hamish Hamilton Ltd., London, 1968.
Gruber, R. E., Steffen, J. J., Vonderhaar, S. P.
Lucid dreaming, waking personality and cognitive development. Dreaming Journal of th Association for the Study of Dreams, 5, 1, 1-12, 1995.
Hakstain, A. R., Cattel, R. B.
An examination af adolescent sex differences in same ability and personality. Canadian Journal of Behavioural Science, 1 (4), 295-312, 1975.
Halliday, G.
Direct alteration of a traumatic nightmare. Perceptual and Motor Skills, 54, 413-414, 1982.
Halliday, G.
Lucid dreaming: use in nightmares and sleep-wake confusion. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Hearne, K. M. T.
Lucid dreams: An electrophysiological and psychological study. Doctoral dissertation, University of Liverpool, 1978.
Hearne, K. M. T.
A suggested experimental method of producing false awakening with possibly resulting lucidity or OBE: The "FAST" technique. Lucidity Letter, 1 (4), 12-13, 1982.
Hearne, K. M. T.
Lucid dream induction. Journal of Mental Imagery, 7, 19-24, 1983.
Hooper, J., Teresi, D.
The 3-pound universe. MacMillan, New York, 1986.
Trad. it: L’universo della mente. Edizioni CDE spa, Milano, 1987.
Kelsey, M. T.
God, dreams and revelation. Ausburg, New York, 1974.
Kueny, S. R.
An examination of auditory cueing in REM sleep for the induction of lucid dreams. Doctoral dissertation, Pacific Graduate School of Psychology, 1985.
LaBerge, S.
Lucid dreaming: Some personal observations. Sleep Reseach, 8, 158, 1979.
LaBerge, S.
Lucid dreaming: An exploratory study of consiousness during sleep. Doctoral dissertation, Stanford University, 1980a.
LaBerge, S.
Lucid dream as a learnable skill: A case study. Perceptual and Motor Skills, 51. 1039-1042, 1980b.
LaBerge, S.
Lucid dreaming: directing an action as it happens. Psychology Today, Jen, 1981.
LaBerge, S.
Lucid dreaming. Jeremy P. Tarcher Inc., Los Angeles, 1985.
LaBerge, S.
Seeing the light in dreams. Paper presented at the annual meeting of the Association for the Study of Dreams, Arlington, V. A., 1987.
LaBerge, S.
Lucid dreaming in western literature. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988a.
LaBerge, S.
The psychophysiology of lucid dreaming. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988b.
LaBerge, S.
Physiological studies of lucid dreaming. In: Antrobus, J. S., Bertini, M. (Eds.): The neuropsychology of sleep and dreaming. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Hillsdale, 289-303, 1992.
LaBerge, S.
Lucidity research, past and future. NightLight, 5, 3, 1993.
LaBerge, S.
Prolonging lucid dreaming. NightLight, 7 (3-4), 1995.
LaBerge, S., Dement, W.
Voluntary control of respiration during REM sleep. Sleep Research, 11, 107, 1982a.
LaBerge, S., Dement, W.
Lateralization of alpha activity for dreamed singing and counting during REM sleep. Psychophysiology, 19, 331-332, 1982b.
LaBerge, S., Greenleaf, W., Kedzierski, B.
Physiological responces to dreamed sexual activity during lucid REM sleep. Psychophysiology, 20, 454-455, 1983.
LaBerge, S., Levitan, L.
Validity established of Dreamlight cues for eliciting lucid dreamig. Dreaming, 5, 3, 158-168, 1995.
LaBerge, S., Levitan, L., Dement, W.
Lucid dreaming: Physiological correlates of consciousness during REM sleep. Journal of Mind and Behaviour, 7, 251-258, 1986.
LaBerge, S., Nagel, L., Dement, W., Zarcone, V.
Lucid dream verified by volitional communication during REM sleep. Perceptual and Motor Skills, 52, 727-732, 1981.
LaBerge, S., Owens, J., Nagel, L., Dement, W.
"This is a dream": Induction of lucid dreaming by verbal suggestion during REM sleep. Sleep Research, 10, 149, 1981.
Leslie, K., Olgivie, R.
Vestibular dreams: The effect of rocking on dream mentation. Dreaming, 6 (1), 1-16, 1996.
Mach, E.
The analysis of the sensations (2nd ed.). Fisher, Jena, 1900.
Malamud, J.
Learning to become fully lucid: a program for inner growth. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Mann, T.
The magic montain. Vintage, New York, 1969.
McCabe, B. F., Ryu, J. H.
Vestibular physiology in understanding the dizzy patient. Rochester, MN: American Academy of Otolaryngology, 1979.
McClintic, R. J.
Pyisiology of th human body, 1975. Trad. it.: Fisiologia del corpo umano. Zanichelli, Bologna, 1983.
McLeod, B., Hunt, H.
Meditation and lucid dreams. Lucidity Letter, 2 (4), 6-7, 1983.
Moers-Messmer, H. Von
Traume mit der gleichzeitigen Erkenntnis des Traumzustandes [Dreams with concurrent knowledge of the dream state]. Archives fur Psychologie, 102, 291-318, 1938.
Moffit, A., Hoffman, R., Mullington, J., Purcell, S., Pigeau, R., Wells, R.
Dream Physiology: Operating in the dark. . In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Myers, F. W. H.
Automatic writings. Proceedings of the Society for Psychical Research, Vol.4, part II, 1887.
Narayana, R.
The dream problem and its many solutions in search after ultimate truth (Vol.1 & 2). Practical Medicine, India, Delhi, 1922.
Olgivie, R., Hunt, H., Kushniruk, A., Newman, J.
Lucid dreaming and the arousal continuum. Sleep Research, 12, 182, 1983.
Olgivie, R., Hunt, Sawicki, C., McGowan, K.,
Searching for lucid dreams. Sleep Research, 7, 165, 1978.
Olgivie, R., Hunt, H.,Tyson, P., Lucesnu, M., Jeakings, D.
Lucid dream and alpha activity: A preliminary report. Perceptual and Motor Skills, 55, 795-808, 1982.
Orme-Johnson, D. W., Haynes, C. T.
EEG phase coherence, pure consciousness, cretivity, and TM-SIDHI experiences. Neuroscience, 13, 211-217, 1981.
Ouspensky, P.
In search of the miracolous. Harcourt, New York, 1949.
Trad it.: Frammenti di un insegnamento sconosciuto. Astrolabio, Roma, 1976.
Ouspensky, P.
A new model of the universe. Routledge & Kegan Paul, London, 1960.
Trad it.: Un nuovo modello dell’universo. Edizioni Mediterranee, Roma, 1991.
Palmer, J.
A community mail survey of psychic experiences. Research in Parapsychology, 3, 130-133, 1974.
Popper, K. R.
La logica della scoperta scientifica Einaudi, Torino, 1970.
Prescott, J. A., Pettigrew, C. G.
Lucid dreaming and control in waking life. Perceptual and Motor Skills, 81, 2, 658, 1995.
Price, R. F., Cohen, D. B.
Lucid dream induction: An empirical evaluetion. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Rapport, N.
Pleasant dreams. Psychiatric Quarterly, 22, 309-317, 1948.
Reed, H.
Meditation and lucid dreaming: A statistical relationship. Sundance Community Dream Journal, 2, 237-238, 1977.
Rotter, J. B.
Generalized expectancies for internal versus extrnal control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1, 609, 1966.
Seafield, F.
The literature and curiosity of dreams. Chapman & Hall, London, 1865.
Shah, I.
The sufis. Octagon Press, London, 1964.
Snyder, M. J., Gachenbach, J. I.
Individual differences associated with lucid dreaming. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Sparrow, G. S.
Lucid dreaming, dawning of the clear light. Simon & Schuster, Virginia Beach, 1972.
Sparrow, G. S.
A personal testimony: Developing lucidity in my dreams. Sundance Community Dream Journal, 1, 4-17, 1976.
Spence, J. T., Helmreich, R. L.
Masculinity and femminility: Their psychological dimentions, correlates and antecedentes. Austin and London, University of Texas Press, 1978.
Stewart, K.
The dream comes of age. Menta Hygiene, 46, 230-237, 1962.
Stewart, K.
Dream theory in Malaya. In: Tart, C., T.: Altered states of consciousness. Garden City, NY: Anchor, 161-170, 1972.
Tart, C. T.
States af consciousness. New York, 1975.
Trad It.: Stati di coscienza. Astrolabio, Roma, 1977.
Tart, C. T.
From spontaneous event to lucidity. 1979. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Tateuki, t. , Myasita, a., Sasaki, y., Inugami, M., Fukuda, K.
Isolated sleep paralysis elecited by sleep interruption. Sleep, 15, 3, 217-225, 1992.
Tholey, P.
Techniques for inducing and manipulating lucid dreams. Perceptual and Motor Skills, 57, 79-90, 1983.
Tholey, P.
A model for lucidity training as a means af self-healing and psychological growth. In: Gackenbach, J. I., LaBerge, S. (Eds.). Conscious mind, sleeping brain. Plenum Press, New York, 1988.
Van Eeden, F.
A study of dreams. Proceedings for the Society for Psychical Research, Vol.26, 1913.
Whiteman, J. H. M.
The mystical life. Faber & Faber, London, 1961.
Witkin, H. A., Dyk, R. B., Faterson, H. F., Goodenough, D. R., Karp, S. A.
Psychological differentiation: Studies in development. New York, Wiley, 1962.
Witkin, H. A., Goodenough, D. R., Oltman, P, K.
Psychological differentiation: Current status. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1127-1145, 1979.
Wolpin, M., Marston, A., Randolph, C., Clothier, A.
Individual difference correlates of reported lucid dreaming frequency and control. Journal of Mental Imagery, 16, (3-4), 231-236, Fal-Win, 1992.
Zadra A.
Recurrent dreams: Their relations to life events. In: Deibre, B. (Ed.): Trauma and dreams. Harvard University Press, Cambridge, 1996.
Zadra, A., Phil, R.
Lucid dreaming as a treatment for recurrent nightmares. Psychoterapy and Psychosomatic, 66 (1), 50-55, 1997.
LINK
LINK INTERESSANTI IN MATERIA DI SOGNO LUCIDO
...Ricerche di Vita
Meditazione, Yoga, seminari sui sogni. Prossimi seminari: 20-21 maggio a Biella, 27-28 maggio 2006 in provincia di Bergamo e 10-11 giugno 2006 a Udine.
The Lucidity Institute
Il sito in lingua inglese diretto da Stephen LaBerge, uno dei massimi esperti del settore.
Associazione europea per le arti terapie
Sito italiano della rivista: "Informazione in psicologia psicoterapia psichiatria". Contiene estratti monotematici della rivista. Il numero 30 è dedicato al sogno lucido.
Afterlife Knowledge
In lingua inglese.
|